
Quando Saverio Campos, il fattore dei conti Valmassoi del Poggio, le chiese di sposarlo, Argentina Servadio gli rispose che si poteva fare ma che lui si mettesse bene in mente che non per questo lei avrebbe rinunciato a Gerico, perché Gerico c’era da prima e ci sarebbe sempre stato, era una cosa a parte, una storia solo sua e senza padroni, e Saverio questo lo sapeva come lo sapevano tutti e accettò a sua volta senza replicare, anzi sentendosi l’uomo più fortunato del mondo perché l’altra cosa importante che sapeva lui e sapevano tutti è che non avrebbe potuto vivere senza la grazia di poter sentire ogni giorno nelle stanze della casa il sospiro delle sue sottane quando lei si alzava presto e spalancava le finestre e il pollaio e le stalle prima di accendere il fuoco, sempre col suo passo piccolo e trafelato di energia mentre insegnava di sua mano alle fantesche come si strizzano le lenzuola lavate al torrente e dal cortile correva in cucina a mescolare paioli prima di scendere in orto a sindacare con l’ortolano la qualità del raccolto, cosicché per tutti gli anni in cui vi fu lei a capo dell’andamento domestico gli albicocchi, i meli, i ciliegi fruttarono più volte durante ogni estate, le vacche sgravavano come conigli, i conigli ingrassavano come maialini, senza contare la qualità del vino dei vigneti, che in bottiglie con le etichette oro e amaranto con le tre palle dei conti del Poggio partiva in vagoni assicurati per le mense di principi regnanti, ministri e arcivescovi; e non replicò né si scandalizzò nessuno in paese anzi era chiaro a tutti che fosse una cosa assai ben fatta, quella di dare al fattore Campos una moglie capace di mandare avanti la grande casa nella tenuta dei conti Valmassoi con la determinazione e il giudizio che aveva solo Argentina, e che la faccenda di Gerico con tutto questo non c’entrava e non riguardava altri che loro due, dato che era cominciata molto prima e non solo non dava fastidio a nessuno ma appariva anzi come una cosa buona e bella e ben fatta anche quella, perché perfino le più schizzinose beghine che non avevano mai avuto un uomo né figli sapevano tutto dell’infanzia di Gerico, famosa per le cinghiate e la catena con cui i suoi genitori lo crescevano nel canile mentre dentro la stamberga loro due si insultavano e si ammazzavano di botte annegati nel degrado di un vino da contrabbandieri, minacciando con lo schioppo e l’accetta chiunque cercasse di impicciarsi del loro inferno. Così anche le vergini e le vedove e le dame benpensanti sentivano quell’antico grumo di sangue tornare a torcersi nei loro uteri vizzi reclamando come sacrosanto un po’ d’amore di donna per quel figlio rinnegato, e pretendendo vendetta per ogni singola maglia della catena da cane che aveva temprato Gerico taciturno al prossimo e indifferente alla fame e al freddo e ai sentimenti tutti tranne quello della fuga, e nessuno avrebbe mai dimenticato che aveva sì e no dieci anni, Gerico, quando riuscì a scardinare la catena del cane e sparì nell’alba, rovinando a balzi sui piedi nudi lungo il costo tra le pietre e gli ulivi finché si lasciò alle spalle la foschia mattutina del borgo e costeggiò prima una segheria poi una fabbrica di cordami e scorse le prime casupole della periferia dove l’odore di salmastro cominciò a guidarlo e lo condusse con sicurezza al porto, a mentire sull’età elemosinando un posto di mozzo a molti capitani finché ne trovò uno che lo prese, anche se in seguito non avrebbe mai saputo dire perché, forse perché aveva sentito subito che dentro quel ragazzino c’era un marinaio, e fu la decisione più illuminata della sua carriera – disse – perché una volta in mare aperto scoprì che aveva anche un’altra dote, quella di confondere le tempeste e farle indietreggiare fino all’orizzonte, cosicché per tutti gli anni che lo tenne con sé la sua nave non incorse in cicloni o uragani e veleggiò sempre placida col vento in poppa mentre altri suoi compari di marineria naufragavano o si incagliavano anche col cielo sereno e la bussola più lungimirante.
E quando Gerico fu uscito dall’infanzia ne sapeva abbastanza da poter diventare capitano a sua volta, non fosse stato per il carattere ombroso e malinconico che lo rendeva inviso agli equipaggi, cosicché gli uomini gli si ammutinavano e nessuno accettò più di imbarcarsi sotto il suo comando. Ma lui continuò a girare il mondo per tutti i mari, come mozzo, come fuochista, come facchino o vedetta, qualunque cosa con qualunque salario anche se doveva stare agli ordini di ufficialetti appena usciti d’Accademia che non sapevano nemmeno stare in equilibrio sul ponte ma pretendevano di essere serviti di tè e crostini giù nel quadrato mentre fuori gli uomini si facevano strappare la cerata dai venti e dalle ondate di traverso; e a vent’anni conosceva più lingue dei professori di Parigi e del Papa di Roma, e non c’era quasi porto o isola che non avesse toccato, da quando in coffa aveva avvistato per la prima volta Capo Verde proprio nell’ora in cui, al paese, la maestra angosciata guidava i gendarmi alla sua ricerca tra i balzi degli ulivi e le tane delle volpi perché i suoi genitori avevano lasciato passare un mese prima di ammettere che sì, il ragazzo era andato via e non si sapeva dove, e nel frattempo avevano continuato a schiantare bottiglie di vino pessimo sui muri della cucina imbrattandosi di schegge vermiglie e di bestemmie. E stava probabilmente stivando casse di rum cubano destinato alla Florida quando suo padre morì del veleno per topi che la moglie gli aveva sciolto nel bicchiere, e pare fosse al limite del circolo polare artico con un carico di merluzzi quando essa soffocò nel sangue del suo stesso fegato squarciato dal vizio, ma queste notizie non gli giunsero se non anni dopo, quando per la prima volta riprese terra e per curiosità decise di salire al Poggio almeno a rivedere il suo vecchio cane.
Il cane era morto di bastonate da tempo, ma in compenso trovò Argentina.
Erano state le suore a chiamarla così, una mattina che erano in cappella per le laudi e avevano sentito suonare a lungo la campanella del portone. Sui gradini c’era una neonata nei suoi stracci, e la via era deserta, nemmeno l’eco dei passi di chi l’aveva abbandonata, solo la scia della campanellina, che per diverse notti tolse il sonno alle monache spaventate. Gerico e Argentina furono messi insieme dal comune destino di orfani indesiderati, e non parve strano a nessuno, nemmeno al curato che anni dopo avrebbe celebrato il matrimonio col fattore, che quei due avessero una strada tutta loro, forse un mondo tutto loro, parallelo ma per questo non comunicante con quello degli altri, in cui riuscivano a rubare alla vita un senso quasi animalesco di riparo e di alleanza che li rendeva invincibili. Anche le beghine rispettarono sempre il loro ineluttabile destino e citavano con ammirazione quasi materna le premure di cui Argentina circondava il suo sposo morganatico quando tornava da traversate lunghe anche mesi e anni, perché non si poteva condannare l’istinto di consolazione di una donna verso un uomo che così poco e male era stato amato nell’infanzia. Saverio Campos, che le responsabilità di fattore dei conti del Poggio tenevano molto occupato e gratificavano fin nel profondo, tutto questo lo capiva, o forse no, ma di certo non disse né fece mai nulla per contrastare i due, anche perché in Gerico non riusciva a vedere un rivale ma solo un uomo più giusto di lui, e poi perché per amore del fruscio delle sottane di Argentina si era abituato a certe mattine in cui lei, alzata prima di tutti, avvertiva il presagio nell’odore del primo caffè, che inspiegabilmente sapeva di salmastro, e allora sentiva con certezza che la nave stava entrando in porto e si affrettava a rassettare i letti e a dare ordini alle donne prima da infilare due cose in una borsa di stoffa sdrucita, salutare tutti col respiro già affrettato e uscire di casa tagliando per i frutteti a terrazze e le scalinate nella roccia fino alla città del porto e all’abbaino dove Gerico a volte arrivava un’ora, due ore, al massimo mezza giornata dopo di lei, sbarcato da navi sfiancate da mesi, e spesso anni, di solitario caracollare in mari senza compassione, col suo involto di panni marchiati di olio e fumo e un titanico bisogno di dormire. Argentina gli faceva trovare la stanza ben arieggiata, il pane nel forno, la tinozza del bagno piena di acqua e salvia, e lì lo metteva, spogliandolo come un bambino, quell’uomo grande e muscoloso come un pescecane, e gli squamava la pelle di tutto il corpo dal sale e dal nerofumo, e dai capelli sgrovigliava frammenti di gusci di conchiglie e code di cavallucci marini, e gli ordinava la barba impiastrata di alghe e sabbia, poi lo asciugava con lenzuola fresche e lo faceva giacere sul letto nel dormiveglia intanto che lavava i suoi panni contaminati da tutte le sentine e da tutti i porti e i loro lupanari, e nel frattempo il pane usciva fulgido dal forno e il paiolo della zuppa fischiava l’ultimo bollore e la tovaglia a quadri sembrava dispiegarsi da sola sul tavolo e loro due mangiavano insieme, solo guardandosi negli occhi, senza parlare, lasciando tutti i racconti e le chimere a dopo, al giaciglio di iuta sotto il lucernario dei loro abbracci profondi come le grotte sottomarine dove smeraldi abissali lanciano bagliori acquatici ai folli che vi si avventurano e ne restano sedotti senza più aria nei polmoni.
Nei quarant’anni della sua fertilità, Argentina partorì otto figli, quattro maschi e quattro femmine, quattro di mare e quattro di terra, quattro di Gerico e quattro di Saverio Campos. Solo lei assicurava di conoscere con certezza a chi era appartenuto il seme che li aveva generati, ma per Saverio la cosa non aveva importanza: i nati dal grembo di sua moglie erano anzitutto di sua moglie e tanto bastava perché lui provasse fin dentro le viscere un amore straziante e un animalesco istinto di protezione. Né il curato, che nel corso degli anni li benedisse tutti uno dopo l’altro in domeniche di festa paesana, mai si sognò di far differenza tra i battezzati di mare e quelli di terra, perché era un buon prete che prima del seminario aveva frequentato i quartieri poveri dei postriboli e dei reietti e aveva capito che certi giudizi sulla morale dei sentimenti era meglio lasciarli a Dio in persona piuttosto che a certi suoi ministri che il troppo studio della dottrina aveva portato mille miglia lontano dalle dimensioni della gente sincera. E Gerico in tutti quegli anni ebbe l’umiltà di non voler mai conoscere i suoi figli di mare, poiché apparteneva al destino di chi riparte più spesso di quanto non faccia ritorno, e non gli era consentito affezionarsi a nessuna parte di se stesso dato che ad ogni viaggio qualcosa di sé la perdeva per sempre, tra le assi di una tolda o dai boccaporti arrugginiti, o anche nei rigagnoli delle calli dei quartieri portuali, e così non voleva accadesse per i figli di mare suoi e di Argentina, che venissero loro a trovarlo una volta grandi, se volevano, se non temevano di incontrare quel pescecane smunto, dalla nuotata guardinga e dagli occhi arrossati che era metà del loro sangue, delle loro ossa e della loro nostalgia. Non poteva permettersi di pensare a loro mentre le settimane passavano tra le secche del mare d’Indonesia o i tifoni dei caraibi, mentre accatastava pesce secco ai confini del mare glaciale oppure vagava tra i vicoli fumosi di antiche città anseatiche in attesa che si levasse quella nebbia mortale che impediva alle navi di salpare, e in quei momenti senza fine il solo pensare a lei, Argentina, era già troppo, assolutamente troppo, era un ansito che gli ruggiva in cuore come di bestia selvatica che si è smarrita in foreste di sterpi là dove invece aveva creduto di trovare la libertà da ogni gabbia, cosicché l’amore che era la gabbia più grande era anche l’unica cui avrebbe voluto tornare e farsi richiudere, per poi, una volta dentro, ricominciare ad ansimare e ruggire nel bisogno intollerabile di evadere di nuovo. E intanto, al Poggio, Argentina continuava ad alzarsi prima degli altri, spalancava imposte, arieggiava tappeti, radunava oche e galline, raccoglieva le loro uova, che erano d’oro e ne trovava dappertutto più volte al giorno, così come le zucche filavano i loro tralci su per gli spigoli della casa e si tornivano sul tetto fra le tegole, e le vacche figliavano e l’orto gettava lattughe come mazzi da sposa e muraglie di pomodori rampicanti, e sui fornelli borbottavano le zuppe, i sughi, gli sformati, e le donne si indolenzivano le braccia torcendo lenzuola estratte immacolate e grondanti dal torrente e ci voleva lei per forzare la strizzatura magistrale e definitiva che le liberava da tutto il peso dell’acqua e le rendeva pronte a dispiegarsi ai buoni venti del costo asciugando in breve tempo tra profumi di erbe selvatiche.
A volte le assenze di Gerico duravano anni, quando gli capitava di poter saltar giù da una nave per imbarcarsi subito dopo su un’altra e riprendere magari lo stesso giro del mondo ma nel verso opposto, tutto pur di poter prolungare ancora un po’ l’ansia febbrile che gli dava il mare e che gli si era impressa nei calli delle mani, nelle squame delle pieghe della pelle, nel continuo fragore di risacca che gli tormentava le orecchie malgrado gli impacchi di malva di uno sciamano del golfo del Messico. Solo Argentiva sapeva per certo quale sarebbe stato il viaggio che lo avrebbe riportato a casa, perché si annunciava ogni volta con quell’odore di salmastro che saliva dal primo caffè della mattina e che avvertiva solo lei. In quelle occasioni, che nel lungo corso degli anni furono assai meno frequenti di quanto si potrebbe pensare, gli occhi grigi di Saverio si facevano color ardesia mentre saliva in cima all’armadio e ne tirava giù la vecchia sacca di stoffa, e le donne si facevano sulla soglia a ricevere gli ultimi ordini mentre lei raccoglieva le due o tre cose da portar via e i bambini promettevano di essere buoni e pettinarsi da soli, e l’ortolano la aspettava sul cancello per consegnarle un cesto di primizie colte all’alba e raccomandarle buon viaggio signora togliendosi il cappello e inchinandosi come un maggiordomo.
Una mattina Argentina si svegliò da un sogno lancinante, in cui stava sciorinando un lenzuolo nelle acque del torrente e il lenzuolo tirava, tirava, era sempre più pesante e si annodava alle pietre infide del fondo, alle radici dei cespugli sulle sponde, e una forza ineluttabile lo trascinava via, lo strappava inesorabile dalle sue mani, lo consegnava a correnti profonde che lo inabissavano tra i gorghi mentre l’acqua continuava a scorrere cancellando l’inutile sforzo e i segni del naufragio, e Argentina seppe con la sua ultima certezza che quello era il corpo di Gerico affidato al mare in un sudario così come aveva sempre predetto e voluto, seppellitemi in mare, e per questo antico voto aveva fatto di tutto, mentito, dissimulato, pur di ottenere un ultimo imbarco ben consapevole di essere verso la sua fine, la fine del suo corpo di pescecane malandato e solcato di cicatrici, abitato da azzardi ancestrali e malattie da angiporto, consumato dalle maree e dall’ossessione del mare aperto, con ricordi di canti di sirene a sfiancargli il cuore e di vele aggrovigliate dagli uragani ad avviluppargli i polmoni.
Argentina non prese il lutto, non ordinò messe di suffragio e rimase del tutto indifferente quando vennero a dirle che lo avevano fatto al posto suo e in suo onore le vecchie pie e pudiche del paese. Era da sola in cucina e mescolava lo zucchero nel caffè quando sentì suonare la campana del Requiem, e solo allora si ricordò che suo marito era ancora a letto perché ormai si alzava tardi e usciva a passeggiare un’oretta col bastone prima di pranzo da quando il fattore era diventato il primogenito Enea, ed era Enea che ora si levava all’alba per percorrere in lungo e in largo la tenuta dei conti del Poggio con la sua nuovissima squadra di agronomi, guardaboschi, contabili e cani da caccia, e gli altri figli e figlie di mare e di terra erano tutti sposati e sistemati per il mondo e in cucina c’era una cuoca giovane e nuovi e giovani erano anche le fantesche, le lavandaie, gli stallieri, gli ortolani, gli uomini di fatica, tutti succeduti alle vecchie generazioni che ancora strizzavano le lenzuola e mungevano le vacche a mano mentre ora c’erano le macchine che ronzavano e producevano senza stancarsi né metterci il cuore. E vide che qualcuno aveva già spalancato le stanze, arieggiato gli armadi, battuto i tappeti, sprimacciato i materassi, lucidato i paioli, spazzato i pavimenti dalle soffitte alle cantine, diserbato i cortili, ingrassato gli attrezzi agricoli, sciacquato a fondo le botti per il vino nuovo, censito tutte le galline, le oche, i tacchini, i conigli, le vacche, e dentro casa i vecchi mobili di famiglia mandavano opulento profumo di cera, brillavano i lampadari e i corrimano, da ogni angolo la polvere era stata sgominata come ogni mattina da quando era lei a mandare avanti la casa e queste incombenze le assumeva di persona, indicando come fare alle servette che le venivano dietro per imparare, e ricordò anche che da allora erano passati tanti anni, e stagioni e malattie, e lutti e figli, tante volte il pane era uscito dal forno perfetto, altre un po’ insipido come tutte le cose della vita e per tutti, e Saverio per quanto vicino agli ottanta complessivamente stava bene salvo un po’ di gotta e i ragazzi erano padri e madri a loro volta ai quattro angoli del mondo e anche lei, Argentina, non aveva di che lagnarsi tranne che era vecchia e tutt’ossa e per aver tanto e intensamente vissuto il suo cuore aggrovigliava i battiti come acciughe nella rete ogni volta che rincorreva le galline o torceva un lenzuolo, e a parte poi che Gerico non c’era più, era in fondo al mare su un letto di sabbia fra luci quiete di pesci d’abisso che passavano a vederlo durante i loro ininterrotti giri intorno al mondo, e tutto era a posto, ogni cosa era in pace e compiuta, e forse c’era ancora tutto il tempo anche per trovare un buon modo di invecchiare e morire decentemente, e allora si mise a raddrizzare i quadri.
 Dopo la morte di David Foster Wallace, mi sono attaccata ancora di più a Don DeLillo nel tentativo di colmare quel vuoto. Mi dico: meno male che c’è rimasto lui, meno male che ha scritto tanto e pare abbia ancora la voglia di continuare, e allora che Dio ce lo conservi un altro po’, dai.
Dopo la morte di David Foster Wallace, mi sono attaccata ancora di più a Don DeLillo nel tentativo di colmare quel vuoto. Mi dico: meno male che c’è rimasto lui, meno male che ha scritto tanto e pare abbia ancora la voglia di continuare, e allora che Dio ce lo conservi un altro po’, dai.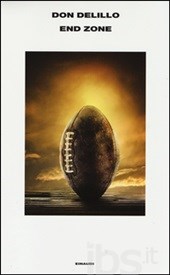 tecnico del football americano, è un romanzo del 1972, ma inspiegabilmente non era mai stato tradotto in italiano fino a quest’anno. È appena il secondo romanzo di DeLillo, che all’epoca aveva 36 anni, eppure è sorprendente l’evidenza del suo talento già compiuto, in nulla inferiore a quello espresso nei romanzi successivi della maturità. La vicenda è quella di un giovane che trascorre un anno in un college dove si incentiva lo sport del football americano, del quale DeLillo è sempre stato un grande appassionato e conoscitore. Si tratta di uno sport in cui la fisicità e l’agonismo sono esasperati al massimo, secondo alcuni una specie di metafora della guerra, anche se, come dice uno dei personaggi, «io rifiuto il parallelismo tra football e guerra, la guerra è guerra. Non abbiamo bisogno di succedanei dal momento che abbiamo l’originale». Il football è al centro del romanzo – che contiene fra l’altro la lunghissima e mirabile descrizione di una partita all’ultimo sangue, una vera e propria prova d’Autore. Ma altri sono i temi toccati: lo spettro della guerra nucleare, l’incomprensibilità della vita, la paura della morte. Il libro racchiude in pratica le inquietudini della generazione di giovani americani degli anni ’60, iniziati con l’assassinio del presidente Kennedy nel 1963 e segnati dalle minacce della guerra fredda e dall’incubo del Vietnam. DeLillo in ogni suo libro ha cantato l’America come un grande Paese contraddittorio; il suo è una specie di canto addolorato e a volte rabbioso, una denuncia accorata dei mali che lo attraversano e lo destabilizzano. Questo non è un romanzo riposante, di evasione. Nessuno dei romanzi di DeLillo lo è. Al contrario, è un romanzo denso, che scava e illumina, in cui ogni parola e frase è necessaria e al suo posto, che si tratti di elucubrazioni mentali, di descrizioni liriche dei paesaggi o di dialoghi solo apparentemente disimpegnati tra studenti.
tecnico del football americano, è un romanzo del 1972, ma inspiegabilmente non era mai stato tradotto in italiano fino a quest’anno. È appena il secondo romanzo di DeLillo, che all’epoca aveva 36 anni, eppure è sorprendente l’evidenza del suo talento già compiuto, in nulla inferiore a quello espresso nei romanzi successivi della maturità. La vicenda è quella di un giovane che trascorre un anno in un college dove si incentiva lo sport del football americano, del quale DeLillo è sempre stato un grande appassionato e conoscitore. Si tratta di uno sport in cui la fisicità e l’agonismo sono esasperati al massimo, secondo alcuni una specie di metafora della guerra, anche se, come dice uno dei personaggi, «io rifiuto il parallelismo tra football e guerra, la guerra è guerra. Non abbiamo bisogno di succedanei dal momento che abbiamo l’originale». Il football è al centro del romanzo – che contiene fra l’altro la lunghissima e mirabile descrizione di una partita all’ultimo sangue, una vera e propria prova d’Autore. Ma altri sono i temi toccati: lo spettro della guerra nucleare, l’incomprensibilità della vita, la paura della morte. Il libro racchiude in pratica le inquietudini della generazione di giovani americani degli anni ’60, iniziati con l’assassinio del presidente Kennedy nel 1963 e segnati dalle minacce della guerra fredda e dall’incubo del Vietnam. DeLillo in ogni suo libro ha cantato l’America come un grande Paese contraddittorio; il suo è una specie di canto addolorato e a volte rabbioso, una denuncia accorata dei mali che lo attraversano e lo destabilizzano. Questo non è un romanzo riposante, di evasione. Nessuno dei romanzi di DeLillo lo è. Al contrario, è un romanzo denso, che scava e illumina, in cui ogni parola e frase è necessaria e al suo posto, che si tratti di elucubrazioni mentali, di descrizioni liriche dei paesaggi o di dialoghi solo apparentemente disimpegnati tra studenti.








