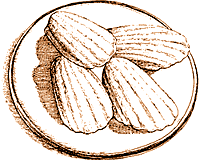Non era così che volevo arrivare a Natale, non così affannata, insoddisfatta e in ritardo con tutto. Avevo programmato bambini docili, papà collaborativo, umori radiosi, estro in cucina e pace nel mondo, e invece il pomeriggio della Vigilia è stata l’ennesima prova di sopravvivenza. Il gatto si è appeso ai festoni dell’albero tirando giù tutto. Il papà ha imprecato così forte da farlo scappare a nascondersi chissà dove, e all’ora di andare a letto non si era ancora rivisto. La figlia di mezzo se l’è presa col papà per via del suo gatto amatissimo ed è corsa a chiudersi in camera sua a piangere istericamente. Il grande si è messo a tirare calci alla porta per farla smettere. I gemelli di un anno hanno cominciato a gridare a squarciagola anche loro, così la tosse gli è aumentata e quasi si strozzavano. Il papà seccatissimo è uscito a prendere un po’ d’aria lontano da questa gabbia di matti, e quando è tornato si è arrabbiato di nuovo perché non era cambiato niente e in più si era accorto di aver perso gli occhiali da riposo.
Non era così che volevo arrivare a Natale, non così affannata, insoddisfatta e in ritardo con tutto. Avevo programmato bambini docili, papà collaborativo, umori radiosi, estro in cucina e pace nel mondo, e invece il pomeriggio della Vigilia è stata l’ennesima prova di sopravvivenza. Il gatto si è appeso ai festoni dell’albero tirando giù tutto. Il papà ha imprecato così forte da farlo scappare a nascondersi chissà dove, e all’ora di andare a letto non si era ancora rivisto. La figlia di mezzo se l’è presa col papà per via del suo gatto amatissimo ed è corsa a chiudersi in camera sua a piangere istericamente. Il grande si è messo a tirare calci alla porta per farla smettere. I gemelli di un anno hanno cominciato a gridare a squarciagola anche loro, così la tosse gli è aumentata e quasi si strozzavano. Il papà seccatissimo è uscito a prendere un po’ d’aria lontano da questa gabbia di matti, e quando è tornato si è arrabbiato di nuovo perché non era cambiato niente e in più si era accorto di aver perso gli occhiali da riposo.
Io in cucina, tentando di portarmi avanti con i preparativi del pranzo di Natale, ho fatto impazzire la maionese per spalmare burro e marmellata sul pane della merenda, afflosciare il soufflé per pulire nasi colanti, lasciato bruciare la zucca per pacificare i turbolenti e dimenticato di scongelare l’arrosto per riordinare il macello in salotto.
Alle sette ho dovuto lasciare la cucina per fare il bagnetto ai gemelli, e sul più bello telefona la cognata per gli auguri in anticipo (domani vanno a pranzo al ristorante, loro!); il papà è stravaccato davanti al televisore e tocca rispondere a me, con il cordless incastrato tra guancia e spalla mentre strofino i piccoli con l’asciugamano. Il grande e la media adesso litigano per la doccia, e il gatto è sparito, forse per sempre, lui, l’unico in questa casa che mi riservava attimi di serenità e languide fusa. Lo sciroppo per la tosse dei gemelli finisce sui bavaglini, gli altri si lamentano perché la minestra scotta e mi sono dimenticata di preparare i crostini; il papà a cena brontola ancora per gli occhiali e incolpa il solito gatto, scatenando nuove crisi di pianto nella figlia gattofila, mentre a me è venuto finalmente il mal di testa tanto aspettato. Inoltre comincio a sentire freddo: l’acqua per lavare i piatti non si riscalda, e capiamo presto che la caldaia è andata in blocco. Che tempismo: ora per parlare con il tecnico dovremo aspettare al freddo tre giorni, e io ho due mocciosi con la tosse e sono freddolosa.
Dopo cena cerco di combinare ancora qualcosa in cucina ma mi sento impotente di fronte al programma in ritardo, e poi col mal di testa non ci ragiono più: meglio andare a letto e rimandare tutto a domattina presto, sperando in qualche miracolo. Del resto il papà a letto ci è già andato perché senza occhiali accidentaccio non riesce a guardare a lungo la tele e poi non c’è niente di interessante da vedere, sempre le solite fetecchie di Natale e uno intanto paga il canone ma perché dico io si può sapere perché.
Devono essere le sei, o almeno lo spero. Spero non sia più tardi, perché ho tantissimo da fare e contavo di approfittare di questi momenti in cui tutti dormono ancora. La prima sensazione è di tepore. Eh sì, i radiatori sono caldini, la caldaia si deve essere sbloccata da sola. Chissà, forse solo una bolla d’aria, Dio ti ringrazio. Dalla cameretta dei gemelli non sento gorgoglii preoccupanti: i loro respiri sono calmi e regolari, e mi rendo conto che hanno dormito tutta notte senza tossire. Il grande ha lasciato scivolare la coperta per terra: piano piano gliela rimbocco addosso, lui si gira con un sospirone felice e grazie a Cielo non si sveglia. La media dorme abbracciata a un peluche che la consola, almeno nel sonno, dalla perdita del gatto. Il papà russa, quindi va tutto bene e continuerà ad andare tutto bene almeno per un’altra oretta.
Io scendo in cucina.
Davanti ai fornelli c’è una vecchina con la crocchia, un vestituccio nero a fiorellini e un grembiule immacolato in vita. Sta mescolando religiosamente una pentola che fuma, e un’altra pentola coperta sobbolle sul fornello accanto sprigionando un soave profumo di ragù mentre, sui ripiani, dei canovacci puliti coprono amorosamente dei vassoi di qualcosa. Il gatto è ricomparso e dorme placido nel suo cestino attaccato al termosifone, come se nulla fosse successo.
“Nonna…” sussurro incantata.
La nonna si gira, mi sorride, posa il mestolo e mi viene ad abbracciare con infinita semplicità.
“Buon Natale, tesoro” mi dice, ed è proprio la sua voce, quella che si è spenta tanti anni fa.
“Nonna… ma non eri morta?”
La nonna è morta quand’ero appena ragazzina. Non sono cose che si possano equivocare o dimenticare. Gli ultimi giorni li aveva passati a casa nostra, i miei le avevano riservato la mia cameretta e il mio letto per farla stare più comoda con la flebo e l’ossigeno, e io dormivo nella stanzetta del guardaroba e ogni mattina salivo a salutarla prima di andare a scuola.
“Guarda, ti ho fatto la pasta fresca” mi dice, indicando i vassoi e i canovacci.
Mi ricordo il tavolone di cucina in casa dei nonni, le vigilie della grandi feste: la sfoglia tirata, le linee tracciate con una riga da disegno di legno, la ciotolona con il ripieno che imparavo a dosare tra pollice e indice per depositarlo nei quadrati, e quel gesto antico e preciso della nonna per chiudere i tortellini che invece non ho mai saputo riprodurre.
“E qui c’è il ragù, lo faccio andare pianino pianino. Intanto è pronta anche la besciamella, è venuta proprio vellutata come si deve” e me ne dà dimostrazione sollevando il mestolo dal quale cola un nastro bianco e cremoso esente dal benché minimo grumo.
“L’arrosto è pronto in forno, già farcito e legato con gli aromi. Il purè dovrai farlo tu all’ultimo momento, ma è facile”.
“Ma nonna, hai cucinato tutto…”
“Ti ho lasciato riposare, ne avevi proprio bisogno”.
Oh sì che ne avevo bisogno, ero così stanca ieri, e avevo tanto mal di testa… ma adesso è sparito, non ce l’ho più, non ho più mal di testa e non mi sento neanche più così stanca. E il gatto è tornato, sono proprio felice!
“Sai dov’era? Si era nascosto dietro la caldaia, qualcosa deve averlo spaventato” mi spiega sorridendo.
Le piacevano i gatti, amava tutti gli animali ma i gatti in modo speciale.
“Lo ha trovato il nonno quando è sceso a riparare la caldaia” aggiunge poi, come se fosse una cosa normale, semplice da capire.
“Il nonno?”
“Lo sai che è un bravo artigiano, un vero aggiustatutto. Ve l’ha sistemata in un attimo, sei contenta? Non potevate mica stare al freddo proprio a Natale, ti pare?”
“Il nonno, il nonno mio! Dov’è, dov’è, che voglio rivederlo!”
“Oh, il nonno, lo sai come è fatto: un po’ orso. Non voleva commuoversi e così ha fatto il lavoro e poi se ne è andato. Ė andato alla stazione a vedere i treni. Gli piacciono tanto, i treni”.
Oh sì, quanto gli piacevano i treni! Da piccola mi portava spesso a vederli, dopo i pranzi di famiglia a casa loro; i grandi restavano in salotto a chiacchierare e noi due uscivamo per fare due passi dopo l’abbondante mangiata, io appesa alla sua mano calda di falegname. Guardavamo i treni di lusso e i notturni, e poi le littorine e i merci, e io imparavo a leggere i cartelli con i nomi delle destinazioni. In tasca aveva sempre delle mentine o delle liquirizie.
“Avrei voluto che conoscesse i miei bambini…”
“Non ti preoccupare. Li ha visti. E gli sono piaciuti tantissimo. Ma loro hanno già i loro nonni”.
Hanno i loro nonni, è vero, ma sono nonni di oggi. Gran bravi nonni, ottimi nonni, moderni, sportivi, però non somigliano a quelli che ho avuto io. Quelli sì che erano nonni, avevano una specie di magia, sembravano personaggi delle fiabe, ed erano capaci di miracoli e incantesimi.
“Ah, guarda che ho spalmato un po’ di Viks Vaporub sul petto ai gemelli: hai sentito come respirano meglio? E gli occhiali di tuo marito erano al loro posto, sul tavolino del salotto ma sotto il giornale. Ora è tutto a posto. E io me ne devo andare”.
Non so se sia stata un’ultima magia, ma mi sono accorta che non mi veniva da piangere come mi sarei aspettata al momento dell’inevitabile congedo. Mi sentivo commossa, sì, ma non era di piangere che avevo voglia, bensì di sorridere e sentirmi straordinariamente felice, come poche altre volte nella mia vita adulta. Più come sapevo esserlo da bambina, direi.
E così l’ho salutata e l’ho lasciata andare, perché il campanile già suonava la prima Messa, e la nonna non avrebbe mai voluto perderla o arrivare in ritardo. Ma io credo che tornerà ancora. Se mi troverò proprio nei guai, io ci credo: tornerà.
(dedicato a nonna Luigia e nonno Giacinto, i veri Custodi della mia lontana infanzia)