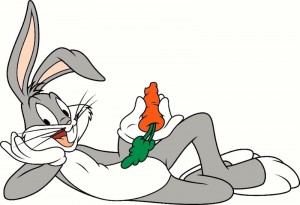A me mi vorrei chiedere scusa per tutte quelle cose che avevo promesso e non ho fatto.
A me mi vorrei chiedere scusa per tutte quelle cose che avevo promesso e non ho fatto.
Perché volevo danzare Lo Schiaccianoci, correre i 100 metri alle Olimpiadi, scavare nella valle del Serengeti, fare il cardiochirurgo, diplomarmi al Conservatorio in pianoforte e direzione d’orchestra, imbarcarmi come mozzo sulla Vespucci, soprattutto diventare una scrittrice, e invece non ho proprio avuto tempo.
A me mi vorrei però anche ringraziare per la pazienza, a volte il fatalismo, più spesso la tenacia e facciamo anche per l’impulsività che qualche volta mi ha pagato e per il resto mi ha dannato, ma pure insegnato. E per l’ottimismo e per il realismo, che insieme formano il pragmatismo che io dico che è la cosa più utile che ho. Senza dimenticare la voglia di fare e un tot di immaginazione che bene o male dà un senso a tante cose che ne avrebbero poco o niente.
A me mi vorrei suggerire di prendermela più comoda, di volermi un po’ più di bene, di dedicarmi un po’ più di tempo tipo per oziare con un gatto addosso o farmi una lunga manicure o cazzeggiare su word come adesso, senza scopo né di lucro né di altro. Soprattutto quando è novembre e piove. E di fissare quanto prima un alberghetto da poco ma affacciato sulla spiaggia per il prossimo giugno senza provare il minimo senso di colpa, che è poi – il senso di colpa – la rogna più brutta di cui soffro e che è ora di mandarla al diavolo una volta per tutte (sapendo come si fa, se qualcuno me lo insegna).
E infine a me mi darei una pacca sulla spalla (la sinistra, ché la destra è fottuta), vecchia mia che cadi eppure sei sempre in piedi, che di cose ne hai fatte comunque, di buone e di cattive, tante inutili, qualcuna speciale, come le mie figlie, come l’inventario della biblioteca e altre due o tre che adesso non ricordo. Avanti così, che ormai di cambiare più di tanto non c’è rimasto granché di tempo, pure se la voglia ci sarebbe.
E smettila di stirare anche gli stracci della polvere.
E curati quella spalla.
Hai capito? Ci sei? Mi ascolti?
A me non mi ascolta mai nessuno.
* * *
campagna (anomala) di sostegno a A TE TI, di Sonupueti, votabile qua
(votabile nel senso DA VOTARE ASSOLUTAMENTE E SUBITO ! ! !)
aderiscono alla campagna:
A noi ci di La Donna Camèl
A egli gli di Hombre
A voi vi di Lillina