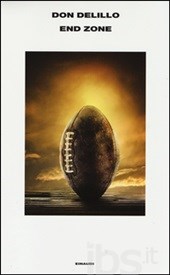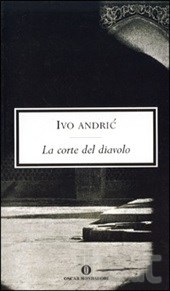Il libro che ho presentato ieri sera in biblioteca al pubblico dei circa trenta Lettori Assatanati del Venerdì è dell’inglese Anita Brookner, oggi ottantaquattrenne, una storica e critica dell’arte che ha insegnato a lungo all’università di Cambridge. È però anche una valente scrittrice, più nota nei Paesi anglofoni che in Italia, ed è stata paragonata a nomi del calibro di Henry James, Jane Austen e Virginia Woolf. Con questo romanzo, Hotel du lac, del 1984, ha vinto il massimo premio letterario d’Inghilterra, il Booker Prize, che equivale al nostro Campiello o allo Strega.
L’ho letto per due motivi. Anzitutto mi è stato consigliato da mia sorella (sì, la cito spesso, ma converrete che ha un suo perché), la quale come lettrice è ancora più assatanata di me e poi legge in lingua originale ed è anche una meticolosa conoscitrice di Virginia Woolf, che anche questo ha un suo perché. Il secondo motivo è che il titolo suggerisce una vicenda ambientata in un albergo. L’idea di un albergo mi interessava perché è uno di quei posti, come chessò un condominio, un treno, una sala d’aspetto eccetera, anche solo una banale coda a uno sportello, in cui va e viene un’umanità varia, fatta di sconosciuti di passaggio che magari non hanno motivo di parlarsi ma che portano, ognuno, una propria storia nascosta. Quindi un ambiente che si presta moltissimo per uno studio di caratteri, un ambiente che molti scrittori amano riprodurre perché consente loro di mettere in scena molte storie diverse all’interno di un’unica storia, con un filo conduttore non troppo vincolante, che lascia ampio spazio all’immaginazione e alla riflessione.
La vicenda dunque si svolge in un vecchio e distinto albergo sul lago di Ginevra, dallo stile aristocratico e forse appena appena un po’ decaduto, ma sempre frequentato da persone altolocate in cerca di un soggiorno tranquillo e confortevole. La stagione è l’inizio dell’autunno, quando ormai i villeggianti più giovani e animati sono ripartiti e rimangono solo ospiti di una certa età, ovviamente facoltosi. In questo albergo arriva Edith, scrittrice quasi quarantenne, una figura dimessa, riservata, malinconica, per un soggiorno che potremmo definire coatto: non è una vera vacanza, bensì una specie di esilio temporaneo cui è stata costretta in seguito a uno scandalo di cui è stata al centro, e che verrà rivelato solo intorno alla metà del romanzo. Edith scrive storie romantiche e ha un buon successo; si è scelta uno pseudonimo le cui iniziali sono V, come Virginia, e W, come Woolf. Anche nell’aspetto somiglia alla grande scrittrice, glielo dicono tutti, e questo particolare ha un suo retroscena curioso nella realtà perché la stessa Brookner, come dicevo, è stata paragonata a Virginia Woolf, e devo dire che sono piuttosto d’accordo.
Questa Edith è un’eroina un po’ fuori moda, se vogliamo, di quelle in gonna di tweed e cardigan; una donna che può ormai dirsi quasi una zitella, che non ha avuto molta fortuna con gli uomini, che ha una relazione segreta con un uomo sposato che non lascerà mai sua moglie, che si aspetta dalle amicizie qualcosa di più che parole e gesti convenzionali. Una donna che vive in penombra, abituata più a subire che a essere protagonista. E in questo momento della sua vita si trova, volente o nolente, nella condizione di doversi tenere ancora più in disparte, e di questa quarantena forzata approfitta per tentare di completare il suo ultimo romanzo ma anche di sottoporre ad autocritica la sua esistenza sull’orlo del fallimento.
All’albergo si trova obbligata dalla buona educazione a frequentare gli altri ospiti. I personaggi più importanti e meglio delineati sono tutti femminili, e la loro funzione è principalmente quella di esaltare il confronto con la protagonista perché tutti, in un modo o nell’altro, rappresentano un mondo di ricchezza, superficialità, vanità, camuffate da successo.
C’è una vecchia nobildonna completamente sorda e per nulla socievole, Mme de Bonneuil: una donna anziana, molto piccola, con la faccia simile a quella di un bulldog, e gambe così arcuate che sembrava ondeggiare da una parte e dall’altra nello sforzo di tenersi in piedi.
Un’altra, più giovane, dall’aspetto affascinante, si chiama Monica: una donna alta, di straordinaria magrezza, con la testa stretta e ciondolante di un uccellino. In lei tutto sembrava esagerato: la statura, la lunghezza delle sue straordinarie dita, la voce imperiosa, gli enormi occhi color ostrica dietro le lenti scure degli occhiali.
Ci sono due donne inseparabili, madre e figlia, Iris e Jennifer, che solo da vicino rivelano la loro vera età: quasi ottanta la prima e verso i quaranta la seconda, ma entrambe giocano a fare le sirene, sono belle, ricche, lussuosamente vestite e ingioiellate, sempre al centro dell’attenzione, ostentando la loro familiarità con gli ambienti più raffinati.
All’inizio Edith è in imbarazzo nei confronti di queste donne così diverse da lei, ma poco a poco capisce che ognuna di loro è una maschera. La nobildonna è una vecchia sola, trascurata dal figlio e dalla nuora e isolata dal mondo anche a causa della sua sordità. La bella donna magra che sembra una flessuosa danzatrice nasconde una storia di nevrosi e frustrazioni. Madre e figlia, così incantevoli, sono in realtà due persone arroganti, superficiali e meschine.
Nel cast vi sono anche degli uomini, ma sono delineati meno acutamente e in fondo si somigliano un po’ tutti. L’autrice, e questo secondo me è un suo limite, li ha disegnati secondo lo stereotipo del maschio egoista che non capisce i misteri della sensibilità femminile e che bada prima di tutto alla propria immagine di uomo arrivato e rispettabile.
Il romanzo si basa quasi tutto su questa analisi di caratteri. C’è pochissima azione, a parte l’antefatto dello scandalo che qui non rivelerò per rispetto di chi volesse scoprirlo da solo; viceversa c’è molta atmosfera, ed è questo che me lo ha fatto apprezzare. Ho anche apprezzato il finale, in cui la protagonista sembra aver preso maggiore coscienza di sé e all’ultimo momento riuscirà ad evitare un altro ennesimo errore.
È una storia in cui l’amore ha il suo peso ma per fortuna non è trattato con eccessivo sentimentalismo, altrimenti non avrei letto fino in fondo. La mano femminile si avverte molto proprio nella capacità analitica e descrittiva e nell’eleganza raffinata dello stile. Un romanzo con un suo fascino, che può fare compagnia senza deprimere, adatto però più a un pubblico femminile.
 Seguo Don DeLillo da anni, ho letto almeno una dozzina di suoi romanzi (cioè quasi tutti) e li ho sempre trovati all’altezza della mia ricerca di una scrittura alta, libera, eclettica, in equilibrio tra sontuosità e minimalismo. Sempre dritta allo scopo, sul bersaglio, con una precisione crudele che si va scoprendo mano a mano che il lettore – mentre si lascia non solo affabulare ma condurre proprio, volente o no, al centro del Male comune dell’esistenza su questa Terra e nell’intero Universo, per non dire nella Storia – ci mette del proprio, ci mette se stesso e si piega a porlo in discussione a rischio di uscirne, nella migliore delle ipotesi, tramortito come dopo una crisi di vertigini parossistiche.
Seguo Don DeLillo da anni, ho letto almeno una dozzina di suoi romanzi (cioè quasi tutti) e li ho sempre trovati all’altezza della mia ricerca di una scrittura alta, libera, eclettica, in equilibrio tra sontuosità e minimalismo. Sempre dritta allo scopo, sul bersaglio, con una precisione crudele che si va scoprendo mano a mano che il lettore – mentre si lascia non solo affabulare ma condurre proprio, volente o no, al centro del Male comune dell’esistenza su questa Terra e nell’intero Universo, per non dire nella Storia – ci mette del proprio, ci mette se stesso e si piega a porlo in discussione a rischio di uscirne, nella migliore delle ipotesi, tramortito come dopo una crisi di vertigini parossistiche.