di Charles Dickens

Un mostro sacro come Dickens, lungi da me recensirlo; posso solo accodarmi devotamente a quanti lo hanno sempre indicato come un Maestro di narrativa, psicologia e arguzia. Un Intoccabile.
Tuttavia mi piace partecipare il godimento che mi ha procurato la lettura di un suo romanzo poco conosciuto, Il mistero di Edwin Drood, ultimo in ordine cronologico nella bibliografia dickensiana e lasciato interrotto dall’Autore nel 1870, quando morì dopo averne completato circa la metà. Il mistero è dunque nel titolo ma anche nella natura stessa dell’opera, della quale rimasero ai posteri solo vaghi appunti scritti e qualche accenno verbale raccolto da amici o familiari. Si incaponì a volerlo completare uno scrittore nostro contemporaneo buon conoscitore dello stile e delle tematiche dickensiane, Leon Garfield, ed è grazie alla sua paziente maestria nonché al talento sorprendente di un traduttore come Pier Francesco Paolini che oggi possiamo accedere a questo lavoro controverso, affascinante, enigmatico.
Due parole sulla trama, che mi permetterò di sintetizzare al massimo: l’Edwin Drood del titolo, un giovane onesto e promettente, scompare misteriosamente, e ne viene incolpato un altro giovane, Neville Landless, altrettanto onesto ma di temperamento alquanto focoso. Attorno a questo nucleo centrale, ruotano diverse vicende di carattere sociale e sentimentale, connesse a una schiera di personaggi dettagliatamente rappresentati e puntualmente inseriti in una cornice ghiottamente deliziosa quale uno spaccato dell’Inghilterra di metà Ottocento (ambientazione e contesto nei quali la penna di Dickens si rivela sempre di impagabile efficacia). Tra i ghiotti ingredienti, un borgo della benpensante provincia inglese dominato da un’antica Cattedrale alla cui ombra si stende un caratteristico camposanto, e poi salotti austeri oppure civettuoli dove si conversa con la studiata retorica del tempo, un collegio per signorine all’insegna tutta vittoriana della serietà e della pudicizia, soffitte malsane per studenti a mal partito o oppiomani derelitti e disperati, una natura affascinante e selvatica che odora del mare vicino.
Ma più che l’intreccio, in quest’opera va rilevata – una volta di più, perché non è certo una scoperta – l’abilità tutta dickensiana di permeare atmosfere lugubri e inquietanti con uno spirito sottilissimo e sornione, che smitizza il racconto a forti tinte proprio con la caricaturale sottolineatura di certe sue inevitabili enfasi. Vien da immaginare il Vecchio Scrittore, avvezzo a ogni aspetto delle debolezze umane da lui costantemente osservate e rielaborate, intento a scrivere le ultime pagine della sua vita – già malato e da tempo – ma ancora e forse più che mai, proprio per la consapevolezza di essere alla fine, immerso nel piacere creativo, nell’ispirazione incontenibile, nel fervore della costruzione di frasi, periodi, capitoli, descrizioni, riflessioni, elucubrazioni particolareggiate fino alla logorrea, come quando la mente è completamente assorta nel prodotto della sua creazione e ci vive in simbiosi, non desiderando che trasmettere ad altri le immagini e le sensazioni di cui alimenta se stessa. Dunque logorrea, forse, ma deliziosa nel risultato per il lettore, al quale resta impossibile non accettare l’invito a lasciarsi coinvolgere in quell’immaginazione, in quella ricostruzione di un mondo che appartiene al passato ma che ci torna così nitidamente delineato da sembrare plausibile e vicino.
Lode al Traduttore Paolini, e al suo mirabile lavoro di mediazione tra noi lettori e uno stile ottocentesco apparentemente arcaico ma aderentissimo alla collocazione e studiato al fine di trasmettere il lavoro dell’Autore con la massima e più leggibile fedeltà, sia sintattica che concettuale.
Un libro – un librone, oltre 500 pagine nell’edizione Bompiani del 2001 – consigliabile nelle lunghe serate invernali, da leggere preferibilmente adagiati in una comoda poltrona accanto a un caminetto acceso mentre fuori piove e tira vento, senza cedere al senso di colpa se la felice evasione ci farà – e con rammarico – spegnere la luce molto tardi.
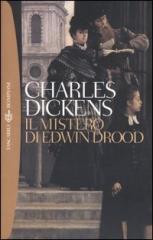
Siccome ogni qual volta il reverendo Septimus si faceva pensieroso, la sua buona madre vedeva in ciò un segno infallibile ch’egli aveva “bisogno di sostegno”, la florida vecchia signora si recò in tutta fretta alla credenza della sala da pranzo per prelevar da essa il necessario “sostentamento”, sotto forma di un bicchiere di Constantia e di un biscotto casalingo. Era una magnifica credenza, degna di Cloisterham e di Minor Canon Corner. Sopra di essa, un ritratto di Händel, in fluente parrucca, sorrideva dall’alto allo spettatore, con l’aria di reputarsi all’altezza del contenuto della credenza, e con un nonsoché nello sguardo che sembrava tradir l’intenzione del musicista di combinar tutte le sue armonie in un’unica deliziosa toccata e fuga. Non era una comune credenza dal volgare sportello che s’aprisse tutt’assieme sui cardini, senza lasciar nulla da scoprire per gradi, no: quella rara credenza aveva una serratura al mezzo, ove due pannelli scorrevoli si congiungevano, perpendicolari; e l’uno calava giù, e l’altro saliva su. Il pannello superiore, nel venir tirato giù (lasciando l’altro scomparto doppiamente sbarrato, nel mistero) rivelava profondi scaffali gremiti di vasetti di sottaceti, barattoli di marmellata, scatole di latta, teche di spezie, e recipiente gradevolmente esotici, bianchi ed azzurri, profumati ricettacolo di conserve al tamarindo e allo zenzero. Ogni benevolo abitante di quel chiostro aveva il proprio nome iscritto sul ventre. I sottaceti, nelle loro uniformi dal pastrano marrone a doppiopetto, con fregi gialli o di colore scuro, si presentavan con il loro nome a lettere maiuscole, in stampatello, come Cetrioli, Cipolle, Cavoli, Broccoli, Carote, Misticanza, ed altri membri della nobile famiglia degli ortaggi. Le marmellate, essendo di temperamento meno mascolino, ed indossando crestine di carta, si annunciavano, in femminil calligrafia, come un tenue sussurro, quali Fragole, Pesche, Albicocche, Prugne, Susine, Mele e Mirtilli. Chiudendosi il sipario su queste tentatrici, e salendo il pannello inferiore, venivan rivelate melarance, insieme ad una scatola di zucchero, laccata, onde temprare la loro acerbità, se poco mature. Biscotti casarecci facevan corte a quelle Potenze, accompagnate da un grosso frammento di focaccia farcita, e da svariati cialdoni detti dita-di-dame, da immergersi nel vin dolce e baciarsi. Più in basso ancora, un ripostiglio foderato di piombo dava ricetto al vin santo e a vari cordiali, e da esso provenivano bisbigli di Arancia di Siviglia, Limone, Mandorla e Semi di Comino. Aveva l’aria, quella regina delle credenze, di aver udito per secoli l’eco delle campane e dell’organo della Cattedrale, un’eco come di ronzanti api, finché quelle venerande pecchie avevan trasformato in miele sublime tutto ciò che essa conteneva nel suo seno; e si osservava sempre che chiunque si immergesse fra quegli scaffali (profondi, come si è notato, da inghiottire testa, spalle e gomiti) ne ritornava fuori con ridente sembiante, come se avesse subito una zuccherosa trasformazione.
