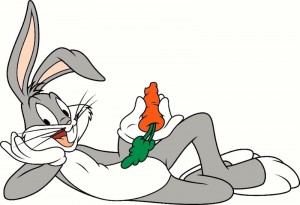Ho molto viaggiato, vi dico, ho girato tutto il mondo; ne ho viste di tutti i colori. E ovunque sia stato, ho sempre veduto il sole sorgere giallo a est e arancione tramontare a ovest. Ora che la vecchiaia mi ha riportato a casa, nei miei occhi continuano a specchiarsi le luci variopinte dell’Oriente anche mentre la nebbia dell’inverno annega i tetti e le cupole della mia città.
Ho molto viaggiato, vi dico, ho girato tutto il mondo; ne ho viste di tutti i colori. E ovunque sia stato, ho sempre veduto il sole sorgere giallo a est e arancione tramontare a ovest. Ora che la vecchiaia mi ha riportato a casa, nei miei occhi continuano a specchiarsi le luci variopinte dell’Oriente anche mentre la nebbia dell’inverno annega i tetti e le cupole della mia città.
Ho molto viaggiato, vi dico, ho girato tutto il mondo; ne ho viste di tutti i colori, e potrei raccontare storie che molti crederebbero inventate. Ah, sapessi dipingere, che quadro farei di quel bazar… ero uscito da palazzo mentre il mio padrone riposava, e mi ero lasciato attirare dal brusio di un grande mercato.
Incuriosito da un insistente tintinnio di campanelli, mi avvicinai ad alcune bancarelle stipate di oggetti colorati e, a prima vista, di difficile catalogazione. Facevano gruppo a sé, un gruppo esotico, disposte a formare quasi un cerchio che lasciava poco spazio in mezzo, così che girandosi ci si trovava subito di fronte dell’altra mercanzia e altri colori. Prevalevano i rossi, dal porpora all’arancione acceso, con molte note violacee e stacchi di blu quasi fosforescente, ma si alternavano anche gli ocra e i marrone, tutti però caldi, vivaci, con un che di vitale come fossero mantelli di animali favolosi dormienti e pronti a svegliarsi. Dietro i banchi, figure insolite dai tratti e dalle vesti orientali, forse di zingari, forse di stregoni. Gli uomini avevano i crani rasati, dalla pelle bronzea e lucida, e nella fusciacca ai fianchi portavano infilati piccoli scudisci o pugnali; le donne invece avevano il capo e il volto velati, e da una fessura orlata di perline si intravedevano occhi lucenti come il plenilunio. Dall’orlo delle larghe maniche ricamate uscivano polsi sottili e magre mani affusolate color della terra, ornate di unghie lunghissime tinte di rosso bruno. Avevano tutti un aspetto fiero e misterioso, più che mercanti sembravano principi del deserto, cosicché le loro mercanzie, disposte con incredibile opulenza sui banchi e per terra, sopra tappeti splendidi, sembravano non oggetti in vendita ma l’esibizione del bottino di un ricco saccheggio o di un tesoro dissepolto da una grotta incantata.
Rotoli di tessuti lucenti, cuscini, velami traforati e trasparenti, fusciacche di colori digradanti, fasce di velluto con appesi campanellini d’argento, ciabattine ricamate con la punta allungata e incurvata, speroni appuntiti, passamanerie a nastri e frange, fazzoletti di velo incrostati di pagliuzze dorate, samovar di smalto, cammelli ed elefantini di giada, tabacchiere di peltro, pipe d’avorio, collane di conchiglie, bracciali di rame, anelli di pietre dure, gioielli raffinati che riproducevano in svariate fogge e materiali le spire di un serpente o teste di animali feroci, specchi incorniciati di legno intagliato, coppe colme di perle di vetro minuziosamente decorate e colorate: di tutto, su quei banchi opulenti e misteriosi, all’ombra di tendaggi che soffondevano una luce rossastra, un’atmosfera surreale. E, su ogni cosa, quel lieve ma continuo tintinnare che proveniva dai molti, moltissimi, turiboli appesi a spandere intorno uno stordente profumo di incensi diversi.
Qua e là, dappertutto, fra mazzi di piume di pavone, denti di drago e fiori di seta, in grandi vassoi laccati stavano raccolti in gran numero dei boccettini di cristallo iridescenti, ognuno diverso per foggia, dimensioni e colore del contenuto, dall’ambra allo smeraldo al rosso sangue al nero assoluto. Quando accennai a sporgermi per prenderne uno, comparve al mio fianco uno di quegli uomini impassibili e muti e mi fermò con un gesto della mano, mentre con l’altra se ne incaricava lui e me lo porgeva. Tolse con gran delicatezza il tappo di cristallo lavorato e mi avvicinò l’imboccatura perché annusassi, in perfetto silenzio. Aspirai un aroma sconosciuto ma incantevole, cui non avrei saputo dare un nome: ricordava un fiore sul punto di appassire, ma sotto emergeva una nota intensa di spezia indecifrabile. Socchiusi un attimo gli occhi per inebriarmi, e solo quando li ebbi riaperti l’uomo annuì e pronunciò una parola, una parola sola e per me incomprensibile, forse il nome di quel profumo, forse una formula magica.
Dopo di quello, me ne fece annusare molti altri, uno dopo l’altro, tutti misteriosi e tutti fortemente speziati oppure dolci, tutti nuovi per il mio olfatto e tutti insinuanti, tali da stregarmi. Di ognuno citava il nome (o forse il potere) senza altro aggiungere, e poi lo posava al suo posto quasi con riverenza, senza mai permettermi di toccare le boccette, come se volesse silenziosamente ammonirmi che quei profumi, quegli unguenti, quei balsami magici non erano cosa per me e potevano anzi nuocere a chi non fosse iniziato alla stregoneria orientale.
Sotto le tende rosse, tra quelle esalazioni di incenso e le fragranze inquietanti dei boccettini, cominciai a provare uno stordimento via via più languido, che mi procurava vertigine, affanno e debolezza alle gambe. Sentivo caldo, mi si annebbiava la vista e nelle orecchie il tintinnio dei campanelli si stava trasformando in un rullo di tamburi che da sommesso andava crescendo di intensità e ritmo fino a sgomentarmi. L’uomo ora non mi porgeva più nulla e restava a guardarmi senza intervenire, quasi studiando le mie reazioni del tutto occidentali e compatendole dentro di sé. Sentii che dovevo strapparmi via da lì, da quel luogo di seduzioni arcane dove non avrei mai dovuto avventurarmi da solo. Girai sui tacchi e fuggii in una direzione qualunque, fuori da quel cerchio di magie diaboliche.
La sera, al banchetto del Kublai, non raccontai nulla al mio padrone per timore che la mia stolta audacia venisse rimproverata. Egli era così sereno, così bello e beneamato, indossava vesti fastose color cremisi e smeraldo, e la benevolenza del gran Kublai si riversava su di lui.
Ma stasera su Venezia è scesa una nebbia densa che tutto cancella e scolora, e anche l’inchiostro della mia penna si è seccato, trattenendo nel suo fondo indaco i policromi ricordi della mia giovinezza.
* * * * * *
Per l’EDS arcobaleno della Donna Camèl, insieme a:
– Tramonti di Angela
– La grande bolgia di Stefano
– Il professore delle favole di Hombre
– Pinocchio di Dario
– Avventura al Policlinico di Il Coniglio Mannaro
– Magia al Polo Sud di Michele
– Madonna segreta di Gordon
– Cicciuzzu Babbaluci di Dario
– Temporale primaverile di Pendolante
– Di padelle ne è piena la Storia di Pernonsprecareunavita
– Frammenti di vita di Lillina
– I custodi del lunedì mattina di Marco
– Spifferi di luce di Stefano
– Alice nel paese dei cosplayer di Leuconoe