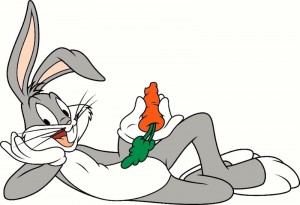Questo racconto (che, vi avviso, è lunghetto) l’ho scritto perché nel mio precedente eds Kermitilrospo aveva notato l’assenza di mortammazzati, e ci si era messa poi anche mia sorella a storcere il naso per l’eccessivo buonismo ottocentesco.
Stavolta, come vedrete se avrete la pazienza di leggerlo tutto (è lunghetto, vi avviso), i mortammazzati non si contano, e spunta anche – forse, spero, mi auguro, ci ho provato – un non so che di sano cinismo post-moderno, nel quale in effetti mi riconosco di più.
Me ne stavo seduta sul mio gradino preferito, il penultimo, perché da lì potevo occhieggiare il marciapiede da un angolo all’altro della strada e verificare, dall’affollamento di cartacce e lattine, il grado di efficienza del servizio municipale di nettezza urbana nel nostro quartiere, e intanto facevo quella cosa stupida che faccio sempre quando sono assorta e/o triste: mi grattavo le ginocchia. Con una specie di affetto, senza graffiare, più che altro un surrogato di carezze e pacche sulle spalle come quelle di cui era carente la mia vita di dodicenne. I gatti risaliti dai seminterrati o scesi dai cornicioni sezionavano scientificamente i sacchi dell’immondizia, riportando alla luce i vassoi di cartone stagnato in cui mia madre e io avevamo cenato con la robaccia unta del cinese all’angolo. Lei aveva smesso di cucinare molti anni prima, il giorno in cui era scomparso mio padre. Molte cose aveva smesso di fare, da quel giorno, e dal momento che già prima ne faceva assai poche si può dire che fu da allora che avevo dovuto farle tutte io. Lei del resto non era in grado. All’inizio, per quasi un anno intero si era dedicata alla ricerca di papà. Era diventata una habituée dell’obitorio, ci andava non meno di due volte al mese, e in certi periodi anche quattro, se aveva fortuna. Ogni volta che ripescavano nella baia il cadavere violaceo e gonfio di un ubriaco, oppure raccoglievano quello stecchito e brinato di un barbone congelato sotto un viadotto della metro, o ancora recuperavano quello raggomitolato nel vomito secco di un tossico in un edificio in demolizione, ogni volta, purché di sesso maschile e privo di documenti – cioè in almeno metà dei casi – facevano un giro di telefonate per invitare le persone che avevano fatto denuncia di scomparsa di un familiare a presentarsi per l’eventuale riconoscimento, e mia madre fra queste.
Per mesi se li andò a vedere tutti, con cura e accanimento, non trascurando nemmeno i cadaveri di razza asiatica e gli afroamericani. Riceveva la chiamata e subito si emozionava come per un appuntamento in centro: indossava un vestito appropriato, dei pochi che aveva, e prendeva un certo numero di autobus per andare fin laggiù. Stava fuori anche diverse ore, perché prendeva la cosa molto sul serio; talmente sul serio che, lungo la strada del ritorno, sentiva il bisogno di fermarsi in qualche bar e concedersi una colazione abbondante, e poi magari un giretto per negozi dove provava vestiti che non poteva permettersi di pagare.
“Come è andata oggi? – le chiedevo educatamente.
“Niente. Era un cinese. Gli somigliava molto, non mi sarebbe dispiaciuto che fosse proprio lui, ma non c’è stato niente da fare: era proprio un cinese – riferiva, delusa.
Oppure:
“Quello di oggi non so proprio come abbiano potuto propormelo. Tuo padre aveva tanti difetti ma, diamine, non certo un occhio di vetro!”
Le piaceva così tanto che a volte andava all’obitorio di sua iniziativa, si affacciava chiedendo garrula “C’è niente per me?” e poi si tratteneva a prendere caffè e ciambelle con gli inservienti fino a mezzogiorno, per tornare a casa se non altro di buon umore per aver passato del tempo con amici.
Per la frustrazione, mia madre si era buttata sul cibo. In forma non era mai stata, era più il tipo tendente al tondeggiante, un tondeggiante sodo e qua e là bozzuto, ma ora si sentiva autorizzata dalle circostanze a introdurre nel suo corpo, senza il minimo riguardo, calorie sufficienti a riempire il vuoto lasciato da mio padre, sotto forma di cibi tra i peggiori, più grassi e malsani potesse trovare al supermercato o nelle rosticcerie più malfamate. Casa nostra si riempì di involucri, cartocci, scatole di pizza, incarti di dolciumi, bicchieroni di plastica di gelato; ingeriva 4 hot-dog e 2 stecche di cioccolato già per colazione, a pranzo scartocciava un vassoio formato famiglia di ali di pollo e patatine fritte, poi per cena diceva di volersi tenere un po’ più leggera e si faceva bastare un paio di pizze e una scatola di gelato. I cioccolatini se li portava a letto, erano quelli della buonanotte, diceva, e presi uno alla volta e così piccoli non potevano farle male. Di tutto questo posso riferire, ma alla mia osservazione sfuggivano gli spuntini che certamente faceva durante la giornata mentre io ero a scuola, e di cui restavano testimonianze nei rifiuti che scovavo sotto il letto quando andavo alla caccia di quei topi che, a un certo punto, cominciai a sospettare coabitassero l’appartamento.
In pochi mesi, mia madre era ingrassata ben oltre il limite dell’obesità media di cui soffre, pare, un’altissima percentuale di americani. Le sue dimensioni avevano qualcosa di sciamanico; il suo corpo non aveva più una forma, ma molteplici forme, e sotto le smisurate vestaglie con cui lo copriva assumeva aspetti sempre nuovi e sempre in movimento, come di materiali ammucchiati maldestramente che tendessero a scivolare uno sull’altro alla ricerca di un assetto meno pericolante, come ondate straripanti che si snodavano e smottavano e si riaccomodavano in balia della forza di gravità, affacciandosi flaccidamente ora all’altezza dell’addome (ormai tutt’uno con le mammelle), ora a quella dei fianchi (ormai tutt’uno con le natiche). Era tutto un ballonzolare, uno spenzolare, uno sgusciare molle, un contorcersi greve come di serpente obeso e moribondo.
Ormai pilotare nello spazio angusto del nostro appartamento quel gigantesco ammasso di carne senza controllo che era diventato il suo corpo era per lei un’impresa che la costringeva a passare di fianco attraverso le porte e a ricorrere a me per qualunque incombenza. Negli ultimi tempi usciva di casa solo per andare, soffiando come un tricheco, all’obitorio, e poiché non era più in grado di salire e scendere dall’autobus si era rassegnata a prendere un taxi, la cui spesa si aggiungeva dolorosamente alle altre più essenziali e contribuiva ad assottigliare i pochi risparmi rimasti. Io avevo cominciato a saltare giorni di scuola perché ero troppo impegnata a occuparmi di lei, della sua interminabile toilette che faceva seduta su uno sgabello rinforzato nella doccia sollevando una dopo l’altra le mammellature davanti, dietro, sopra e sotto affinché ci passassi un asciugamano insaponato e la pasta allo zinco per dare sollievo alle piaghe fetide e melmose ospitate nel fondo di ogni piega.
Un giorno, dopo quasi un anno, tornando a casa da scuola la trovai seduta in cucina in compagnia di due tipe dei Servizi Sociali. Una di esse si alzò per venirmi incontro e con un certo garbo compunto molto professionale mi annunciò che quella mattina mia madre aveva riconosciuto papà nel cadavere di un uomo rinvenuto in un vagone merci in disuso abbandonato da anni su un binario morto. Mia madre guardava nel vuoto e non mi parve sconvolta, aveva le labbra strette come stesse riflettendo e ogni tanto annuiva a se stessa. Quando restammo sole, non mi disse molto: solo che ora dovevamo pensare a noi stesse e che quelle due brave signore ci avrebbero aiutate. Io ero così abituata a pensare mio padre come morto che averne avuto la conferma non cambiò molto le cose.
Invece le cose cambiarono. I Servizi Sociali ci riconobbero un assegno di sostentamento e controllarono che non mancassi più alle lezioni. Una volta ogni tanto passava qualcuno a chiedere se avessimo bisogno di qualcosa, ci portavano bende e pomate per la mamma, abitucci usati per me. Ma la più grande novità fu che mia madre si mise a fare progetti. Un giorno mi disse che si era trovata un lavoro, un lavoro da svolgere in casa. Mi disse che la sua lunga frequentazione dell’obitorio l’aveva illuminata, le aveva fatto scoprire di possedere una dote che ci avrebbe fatte ricche: la dote di saper parlare con i morti. Nel quartiere la notizia non stupì, e la clientela, fatta per lo più di vedove superstiziose, non tardò a raccogliersi numerosa.
Mia madre per l’occasione evocò lontane origini pellerossa e si impadronì dello spirito di una bisnonna Cherokee, prendendone a prestito il nome, Esmeralda, e l’acconciatura, una parrucca con lunghe trecce corvine con la quale nascondeva i capelli stopposi e rarefatti vittime di decenni di sciagurate tinture nonché degli squilibri nutrizionali. Riceveva nella saletta da pranzo, sacrificata a studio esoterico e addobbata di drappi neri alle pareti e di un’oggettistica dissennatamente ibrida che comprendeva simboli indiani, zampe di conigli, teschi di gatti, campanellini buddhisti, candele da catacomba, fotografie di ectoplasmi. Aromi di incensi di poco prezzo coprivano la puzza dei cibi e dello zinco rancido. I clienti arrivavano riverenti, in soggezione, e li accoglievo io, conciata con una tunichetta di pizzo tinto di nero che cominciò presto a starmi stretta ma che mi conferiva dignità e mistero. Li introducevo al cospetto della sciamana Esmeralda e poi mi ritiravo, per ricomparire solo al termine della seduta e incassare la tariffa, che non era esosa ma nemmeno modesta. Mia madre non voleva che assistessi, e da dietro la porta sentivo solo qualche mormorio e un tintinnare di sonagli che significavano l’arrivo dell’anima richiesta. Le anime rispondevano sempre alla chiamata. Ogni vedova, ogni orfano ultrasessantenne, ogni decrepito reduce di Corea ansioso di ricollegarsi a un vecchio commilitone caduto, tutti avevano il loro momento magico e misterioso, il loro contatto dall’aldilà, risposte alle loro domande, conforto alle loro nostalgie. Mia madre non so come facesse, ma dispensava del bene a tutti. E di quell’attività campavamo.
Me ne stavo, insomma, sul penultimo gradino e mi grattavo sconsolatamente le ginocchia, quando dall’angolo della strada vidi avanzare, col suo inconfondibile passo danzante, mio padre morto da cinque anni.
La sua andatura era quella delle persone molto alte e smilze, di un giocoliere, o forse di un giocatore di basket sul parquet: dondolante, rilassata e piacevolmente controllata. Il gesto gli partiva dalle spalle, come si apprestasse a cingere una donna per un giro di valzer, e si trasmetteva alle lunghe gambe leggermente arcuate, poi ai piedi che sembravano accarezzare il suolo con la leggerezza di un Fred Astaire.
Avanzava lungo il marciapiede sorridendo fra sé come un fanciullo in vacanza, le mani nelle tasche dei pantaloni color verde stagno, una giacca di velluto assai frusto color melanzana, scalciando affettuosamente le cartacce che i suoi piedi incontravano e puntando verso casa nostra. Quando mi fu vicino, si inclinò un po’ per scrutarmi attentamente e mormorò cantilenando:
“Guarda guarda Betty Lou come si è fatta grande…”
Io, dico la verità, non feci quello che sarebbe stato ovvio per chiunque: non mi alzai di colpo, non mi impressionai, non tentai di ritrarmi per lo spavento né feci domande con voce strozzata. E lui non fece niente di quello che ci si sarebbe potuto aspettare: non mi sfiorò, non mi accarezzò i capelli, non fece il gesto di abbracciarmi. Ci guardammo per qualche istante, forse rimandando tutto a un altro momento.
Poi lui disse, educatamente:
“Beh, io salgo un attimo”.
E io rimasi lì su quel gradino, senza pensare a niente, perché qualunque cosa avessi pensato certamente era troppo grande per me. I gatti selezionavano gli avanzi, raspando fino all’ultima molecola le carte oleate della rosticceria e lasciando ai cani, che sarebbero sopraggiunti più tardi e che notoriamente mangiano di tutto, la stagnola del cioccolato del resto già meticolosamente leccata da mia madre.
Non rimase di sopra a lungo, diciamo un quarto d’ora secondo la mia incerta percezione di dodicenne. Io non mi ero mossa, e lo sentii alle mie spalle lasciar ricadere il portoncino e saltellare giù dai gradini con lo stesso lieve atteggiamento fanciullesco e malandrino di quando era salito.
Ora mi aspettavo, che ne so, una frase, qualcosa, qualcuna di quelle cose che prima ritenevo avessimo solo lasciato in sospeso, e dentro di me pensavo che non ne avevo poi un gran desiderio, perché poteva saltar fuori una situazione ben più che bizzarra o imbarazzante. E io di situazioni bizzarre e imbarazzanti ero, a dir la verità, anche abbastanza stufa.
“Dice tua madre di salire per aiutarla a mettersi a letto – mi informò con gentilezza, e in quel momento sentii il suo odore, che era di elefante, e vidi che aveva i capelli raccolti in un codino e ai polsi portava due braccialetti di misere perline.
Poi se ne andò, verso l’angolo di strada da dove era svoltato, ma a metà si fermò un attimo, mi chiamò:
“Ehi!”
E mi lanciò qualcosa, che io fui svelta ad afferrare tra le mani.
Poi un ultimo gesto di saluto, e fu tutto.
Mi aveva donato un pacchetto di sigarette, ciancicato e mezzo vuoto. Lo guardavo chiedendomi se un padre che regala sigarette a sua figlia di dodici anni è un padre molto moderno, oppure nessun padre.
Mia madre mi aspettava sulla sua poltrona sfiancata. Senza una parola le sfilai le calze dalle gambe pachidermiche e l’immensa tuta di ciniglia di un fragoroso color fragola, le rinnovai gli strati di garze intrise di pomate puzzolenti, raccolsi da terra i resti di un paio di scatole di cioccolatini e la scortai nella penosa navigazione verso il letto.
Fu solo quando si fu sistemata con molti ansiti e gemiti e il suo immane corpo ebbe finito di spargersi, dilagare e invadere il materasso, che mi parlò. Era provata ma durissima, determinata.
“Nessuno deve saperlo. Giura che non lo dirai a nessuno. A nessuno, capito?”
“Ma allora non era morto davvero?”
“A nessuno, ti dico, a nessuno – ribadì con forza.
Poi aggiunse:
“Non piangere. Pensa solo a questo: se qualcuno lo viene a sapere, noi perderemo il sussidio, e io perderò la mia reputazione. Ho un lavoro onorato, la gente crede in me. Non vuoi rovinare tutto, vero? Dimmi che non vuoi”.
Io non è che stessi piangendo, né ne avevo l’intenzione. Trovavo solo ingiusto che certe cose succedessero un metro sopra la mia testa.
“No che non voglio, ma se lui tornasse? – tentai, per farla ragionare.
“Ah no che non torna, puoi star sicura. Gli ho detto che se torna lo ammazzo con le mie mani – mi assicurò, e la sua voce era colma di desiderio di vendetta. Capii che parlava seriamente, e del resto disponeva di un’arma letale: il suo stesso peso, con il quale avrebbe potuto mantenere la minaccia col solo accasciarglisi addosso e schiantarlo come un qualunque sgabellino di bambù.
“Ma tu lo sapevi, però – protestai debolmente.
Lei non rispose. Un giorno, cinque anni prima, aveva fatto la sua scelta, e oggi non le restava che ribadirla.
Quella notte mi svegliai di soprassalto perché mi ero dimenticata di controllare una cosa. Tirai fuori dal comodino il pacchetto di sigarette e lo esaminai per bene: ne conteneva cinque, storte, mezze morte, mezze sbriciolate. Cercai dentro e fuori se vi fosse un biglietto, un messaggio, un indirizzo.
Ma era solo un pacchetto cincischiato e mezzo vuoto, giusto con un fondo di odore di elefante.
* * *
E anche con questo partecipo all’eds Nero di Natale della solita stregonessa Donna Camèl, in ottima e abbondante compagnia con:
Hombre con Ti prego, non chiamarmi Barbie
Dario con Zebre e savane
Leuconoe con Placida come il fiume
Pendolante con Natale con soffritto
Kermitilrospo con Pedalata nera
Fulvia con Il quadro capovolto – 2a parte
Lillina con Una vita segnata
Calikanto con Nero livido
La Donna Camèl con Se tu mi amassi
Singlemama con Dissolvenza in nero
Angela con Chi è di scena
Angela (ancora) con Taccido