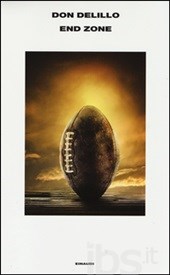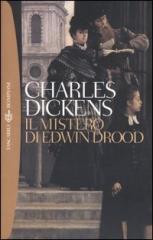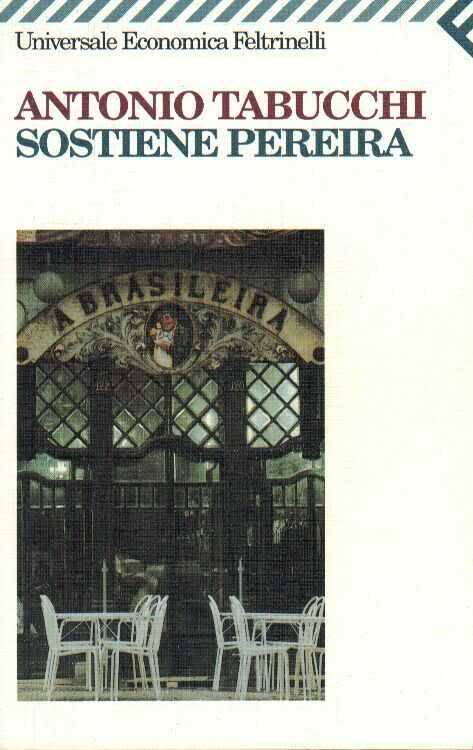di Antonio Tabucchi
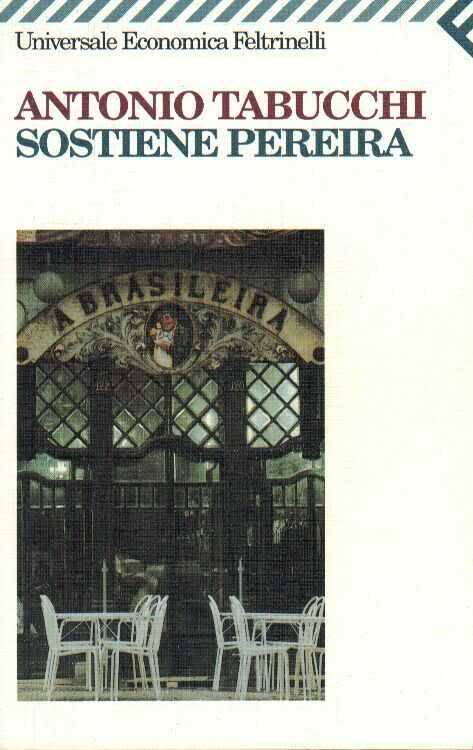
Quando ho preso in mano questo romanzo – circa 200 pagine, di cui molte, tra un capitolo e l’altro, bianche – ho calcolato che mi avrebbe richiesto non più di tre serate, e che presto avrei potuto affrontarne un altro dei tanti in attesa di lettura.
Mi sbagliavo: tre serate non sono bastate.
E non perché il libro mi sia risultato di ardua comprensione o abbia preteso da me una concentrazione che mi è difficile conservare a lungo nelle ore notturne, ma al contrario perché fin dalla prima pagina mi ha sedotta al punto che ho fatto il possibile per centellinarmelo, assaporarlo, trattenerlo con me per allontanarne la fine, quel momento di tristezza che segna il distacco da una lettura amata e che si trasforma da subito in nostalgia.
Per sapere con certezza che mi sarebbe piaciuto, mi è bastato l’incipit, quelle prime cinque, brevi, efficacissime frasi in cui avviene con magistrale immediatezza l’introduzione all’ambiente e al personaggio. In poche righe, sappiamo già di trovarci in una Lisbona estiva azzurra, ventilata e scintillante, esattamente come la immaginiamo, come ce la raffiguriamo quando sogniamo di arrivarci da visitatori, e di avere a che fare con un uomo dedito alla cultura e alla meditazione, ma non un intellettuale spocchioso o un alto filosofo, bensì un animo dimesso, un abitudinario ripiegato su se stesso e sulla piccola serenità di alcune certezze un po’ stantie, un antieroe modesto e appartato, esente da presunzioni o ambizioni. Pereira, di cui non sarà dato di conoscere che il cognome col quale firma i suoi articoli, è un giornalista di mezza età, vedovo, affetto da pinguedine e dagli affanni di una lieve cardiopatia, che vive tra il suo appartamento ordinato, l’ufficio dove svolge il suo lavoro in solitaria – poco più di un bugigattolo – e un piccolo locale, il Café Orquìdea, dove prende spesso i pasti. Gli tengono compagnia pochi e semplici punti di riferimento: il suo interesse per la letteratura, alla quale si dedica scrivendo traduzioni di autori francesi dell’ottocento – anacronistici ma politicamente corretti – in qualità di redattore culturale di un modesto giornale del pomeriggio, e gli affetti per il passato, prima di tutto la moglie morta da anni con la quale parla attraverso il vetro di un ritratto, e poi i ricordi della sua animata gioventù universitaria a Coimbra. Queste consuetudini quotidiane, di cui pare non avvertire l’opacità, gli sono sufficienti per comporre giorno dopo giorno quel che resta della sua vita, anzi gli occupano e gratificano la mente al punto di appannare la percezione della realtà esterna, che in quei mesi (siamo nel 1938) sta prendendo, e non solo in Portogallo, aspetti sempre più minacciosi. Ma Pereira di quanto sta avvenendo nel suo Paese e nell’Europa intera si tiene al corrente in modo distratto, quasi volendo rimanerne fuori, dai resoconti veloci di Manuel, il cameriere del Café Orquìdea, che quasi ogni giorno gli serve le sue ordinazioni preferite, ancorché poco salutari: omelettes alle erbe e bicchieroni di limonata ghiacciata, un menu-tormentone al quale finisce per affezionarsi anche il lettore. Pereira pare un uomo che si sia ritirato dalla vita attiva, rinunciando a ogni analisi critica non tanto per viltà quanto per una larvata forma di depressione, di autodifesa forse; quella che applica spesso davanti a problemi o interrogativi cui non sa reagire, e che gli fa rinviare lo studio delle possibili soluzioni o risposte con dei dimessi “Beh, pazienza” oppure “Beh, vedremo”.
Questa routine consolidata e rassicurante comincia a mostrare la corda in seguito ad alcuni incontri, tutti e ciascuno determinanti, che lentamente – quasi controvoglia – la destabilizzano, mettendo in luce il suo anacronistico grigiore, la sua ottusità nei confronti del mondo esterno e dei suoi rivolgimenti che, malgrado Pereira abbia scelto di restarne estraneo, stanno prendendo una piega drammatica e cominciano a coinvolgere direttamente anche lui.
Dapprima entra in scena un giovane studente, Francesco Monteiro Rossi, scrittore squattrinato che si rivela oppositore del regime salazarista e porta con sé, oltre all’alito della giovinezza, anche il vento inquietante della rivoluzione; è lui il primo a introdurre nella statica vita dell’anziano giornalista la presenza imbarazzante di istanze di contestazione e ribellione, che emergono dagli articoli che scrive e gli propone, e che Pereira trova tutti immancabilmente impubblicabili, estranei come sono alla prudenza che di quei tempi informa la diffusione delle idee.
Poco dopo, è la volta del dottor Cardoso, un medico dalle idee aperte e dalla filosofia pacata, che apre gli occhi a Pereira sugli aspetti della libertà di coscienza, pur senza forzare la mano o fare opera di proselitismo, al contrario proponendosi come ascoltatore, confidente, interlocutore sereno e saggio, portatore di alcune di quelle risposte che a Pereira mancano da tempo.
Da ultimo, un episodio che occupa solo pochi (e splendidi) paragrafi ma che ha il suo peso: la conversazione casuale, su un treno, con una certa signora Delgado, una donna ebrea che racconta brevemente la sua esperienza di perseguitata e insinua in Pereira l’inquietudine per il futuro che aspetta tutti, suggerendogli perfino di esercitare gli strumenti della sua professione per mobilitare le coscienze.
Da questi incontri, il mite giornalista ricava un senso di turbamento che lo spinge a ripensare alla sua vita e alle sue motivazioni, scoprendole insufficienti e addirittura ingannatorie. Prende nebulosamente consapevolezza delle storture della società che lo circonda e in cui finora si era sentito avvolto come in un guscio, e inizia a rendersi conto dell’impostura salazarista che si è già insinuata fino al nucleo centrale del suo stesso lavoro, condizionando le scelte editoriali, ormai da tempo soggette a una censura politica più o meno esplicitamente espressa.
La narrazione assume il profilo del romanzo civile, e segue fino all’epilogo tragico la vicenda del giovane rivoluzionario nella quale resta gradualmente e sempre più pericolosamente coinvolto un Pereira già oscuro e fatalista e che ora sta compiendo quasi senza saperlo un percorso di svecchiamento e autoconsapevolezza, un rinnovamento interiore prima impensabile e portatore di una nuova carica di energie mentali, di dignità e di coraggio. Passando attraverso l’esperienza della violenza, della sopraffazione e dell’omicidio di polizia, Pereira si libera del suo vecchio abito miope e rinunciatario e riprende possesso della sua vita, progettando per sé – come ultimo gesto – un futuro ancora non esattamente definito ma certamente assai diverso.
Al di là del significato della storia e delle sue implicazioni, quello che per me è il pregio maggiore di questo grande romanzo è il registro equilibrato che lo accompagna dall’inizio alla fine e che non scade mai, nemmeno nelle pagine di più dichiarato valore morale e politico, né nella propaganda né nella celebrazione né nel comizio censorio, ma conserva con finissimo equilibrio una costante pacatezza di tono. Lo stile è blando, non ornato, quasi casuale, ma si intuisce la mano esperta dell’Autore nel mantenerlo uniformemente controllato su un registro medio-basso che pare scelto apposta per seguire e sottolineare il ritmo lento e un po’ incespicante delle giornate di Pereira, dei suoi passi faticosi per l’afa e la fiacchezza del cuore, delle ore di solitudine e opaca meditazione, ma soprattutto il ritmo sonnolento della sua stessa coscienza.
Di questo libro, uscito nel 1994, si disse e si dice che contiene una ferma condanna all’imbavagliamento della stampa da parte dei regimi totalitari, tanto che fu usato come manifesto dall’opposizione di sinistra nei confronti del monopolio berlusconiano dell’informazione, ma a me pare evidente che il messaggio di Tabucchi vada ben oltre queste contingenze nostrane, indicando un valore superiore e universale quale quello, più ampio, del risveglio della coscienza e della fiducia in ogni e qualsiasi redenzione. E trovo assolutamente ammirevole la capacità tecnica dimostrata da Tabucchi nel trasmetterlo senza cadere nell’uso di effetti convenzionali o di sermoni edificanti; il suo linguaggio sobrio, senza impennate, senza ammiccamenti, è il mezzo migliore per affrontare temi così fondamentali partendo però dal basso, dalla dimensione umana, dall’individuo e dal suo microcosmo, invece che porsi in cattedra predicando verità scontate e convenzionali. Un linguaggio che si sublima nella chiusa, un piccolo capolavoro nel suo genere, in cui si condensa il senso stesso dell’esistenza umana e delle sue risorse e in cui si indica un futuro la cui maggiore ricchezza è proprio l’indeterminatezza che ne fa territorio di conquista per chi ne auspica uno comunque migliore.
“Era meglio affrettarsi, il Lisboa sarebbe uscito fra poco e non c’era tempo da perdere, sostiene Pereira”.
 Seguo Don DeLillo da anni, ho letto almeno una dozzina di suoi romanzi (cioè quasi tutti) e li ho sempre trovati all’altezza della mia ricerca di una scrittura alta, libera, eclettica, in equilibrio tra sontuosità e minimalismo. Sempre dritta allo scopo, sul bersaglio, con una precisione crudele che si va scoprendo mano a mano che il lettore – mentre si lascia non solo affabulare ma condurre proprio, volente o no, al centro del Male comune dell’esistenza su questa Terra e nell’intero Universo, per non dire nella Storia – ci mette del proprio, ci mette se stesso e si piega a porlo in discussione a rischio di uscirne, nella migliore delle ipotesi, tramortito come dopo una crisi di vertigini parossistiche.
Seguo Don DeLillo da anni, ho letto almeno una dozzina di suoi romanzi (cioè quasi tutti) e li ho sempre trovati all’altezza della mia ricerca di una scrittura alta, libera, eclettica, in equilibrio tra sontuosità e minimalismo. Sempre dritta allo scopo, sul bersaglio, con una precisione crudele che si va scoprendo mano a mano che il lettore – mentre si lascia non solo affabulare ma condurre proprio, volente o no, al centro del Male comune dell’esistenza su questa Terra e nell’intero Universo, per non dire nella Storia – ci mette del proprio, ci mette se stesso e si piega a porlo in discussione a rischio di uscirne, nella migliore delle ipotesi, tramortito come dopo una crisi di vertigini parossistiche.