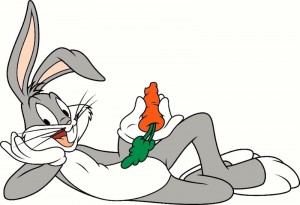Nell’ottobre del 1895, agli esordi della mia fortunata carriera di neuropsichiatra, mi imbattei in un caso a dir poco arduo e insieme commovente, che avrebbe cambiato la mia vita in un modo inatteso.
Nell’ottobre del 1895, agli esordi della mia fortunata carriera di neuropsichiatra, mi imbattei in un caso a dir poco arduo e insieme commovente, che avrebbe cambiato la mia vita in un modo inatteso.
Me ne incaricò il professor Waldenstein, decano all’Hôtel Dieu, del quale ero stato l’allievo prediletto. Si trattava di una giovane donna dell’alta società che aveva perduto la memoria in seguito a un trauma emotivo dei più brutali: il marito era morto annegato sotto i suoi occhi nel mare di Capri durante il viaggio di nozze in Italia, e non riesco davvero ad immaginare un epilogo più straziante per quello che appariva a tutti un perfetto matrimonio d’amore. L’amnesia che l’aveva colpita aveva cancellato dalla sua mente tutti i ricordi antecedenti l’incontro con il futuro marito, risucchiando perciò nell’oblio la sua infanzia e le immagini dei suoi stessi familiari. Essa li riconosceva per tali solo perché le era stato provato che lo erano, ma tuttavia non rammentava di aver mai visto prima i loro volti né pronunciato i loro nomi. Incapace di ambientarsi nella sua famiglia d’origine, si era ritirata nella casa maritale, dove viveva infelice coltivando gli unici ricordi sopravvissuti, che le parlavano di un amore e di una felicità durati così poco e ormai perduti per sempre.
Acconsentii a occuparmi del suo caso dopo averlo frettolosamente classificato come una amnesia isterica, statisticamente abbastanza frequente fra i soggetti di sesso femminile soprattutto se giovani, benestanti e sensibili, e, confidando in un pronto successo, la ricevetti nel mio studio privato al pianterreno della villa di Neuilly dove dimoravo da solo.
Essa quel giorno, come poi tutti i seguenti, indossava un abito nero di ottima fattura e calzava un cappellino dello stesso colore, la cui veletta le copriva il volto lasciando trasparire solo il tenue rosa delle labbra.
Quel primo incontro fu dedicato a raccogliere quanti più dati possibile, ma a fine giornata mi resi conto di avere ben poco in mano: nulla che comunque non mi avesse già anticipato nel dettaglio il mio Maestro, perché dalla bocca e dalla memoria della mia giovane paziente non uscì null’altro di illuminante. E così anche negli appuntamenti seguenti: essa non faceva che ripetere le stesse frasi, rievocare le stesse scene, ribadire la propria impotenza davanti a quel muro nero che le si parava dinnanzi ogni volta che cercava di spingersi indietro nel passato.
“Un muro, voi dite”.
“Un muro. Un muro nero”.
“Nero come? Anche il nero è un colore, e dunque può avere varie tonalità, vari registri, a seconda di quale prevalga fra i suoi tanti componenti… ”
“Nero, signore. Nero. Non ci sono sfumature, è tutto nero”.
“Nero come la notte? La notte ha qualcosa di blu profondo. O come la seta del vostro abito? Però contiene dei riflessi argentei, smorzati ma comunque riconoscibili”.
“Se intendete dire che anche in un pozzo, anche in una grotta, il buio può essere sempre interrotto da qualche lieve bagliore, ebbene non è il mio caso. Il nero del muro che abita in me è definitivo e ineluttabile come l’interno di una tomba molti metri sotto terra, signore”.
La sua patologia persisteva ormai da qualche mese, e si era mostrata refrattaria ai principali rimedi posti in essere: non le avevano giovato né calmanti né eccitanti, né viaggi all’estero né riposi in un chiostro, né soggiorni al mare né in montagna, né applicazioni calde o fredde o elettriche o magnetiche, e nemmeno l’ipnosi. Il muro resisteva nel fondo della sua mente, nero e crudele, solido e beffardo.
“Vi scongiuro – mi supplicava – fate qualcosa. Finora tutto è stato inutile, e il tempo passa privandomi della gioia di vivere. Presto invecchierò senza mai essere stata giovane!”
Ah, essa che paventava la propria vecchiaia non aveva che ventuno anni! Si può immaginare nulla di più straziante? Quanto atroce era il suo destino di ricordare solo un marito oramai perduto e irraggiungibile e di non potersi rifugiare con confidenza nel grembo della famiglia che tanto l’amava e a cui si sentiva estranea? Sarebbe stato preferibile il contrario, e forse sarebbe stato anche più facile da curare.
Avevo adottato fin dall’inizio un mio metodo personale: durante la seduta, le facevo indossare sopra gli occhi una benda nera ben accomodata in modo da precludere il passaggio di qualunque spiraglio di luce. Lo scopo era quello di ricostruire in concreto la sensazione di muro nero e di stimolarla affinché si sforzasse di vedere oltre, di scavare quella superficie e scoprire al di sotto i tenui disegni dell’affresco del suo passato. Pronunciavo parole e nomi di luoghi che avrebbero dovuto rievocarle qualche ricordo fondamentale, oppure le facevo toccare oggetti che avrebbero dovuto esserle familiari, come la bambola preferita di quand’era bambina o il collare dell’adorato cagnolino dei genitori, ma pareva ormai che anche quei tentativi dovessero restare infruttuosi.
Un pomeriggio di tardo autunno (la luce era scesa presto, pioveva a raffiche e il vento dall’Atlantico frustava le imposte), nel corso di un colloquio particolarmente impegnativo accadde qualcosa di sorprendente. Ad un certo punto, mi accorsi che era molto provata e aveva il mento e le mani tremanti.
“Perdonate, ma sono troppo stanca per continuare. E a dire il vero ho molto freddo… – mormorò.
Subito mi adoperai perché si riprendesse, e la sorressi fino alla poltrona più vicina al caminetto, dove ardeva per la verità un fuoco più che sufficiente a riscaldare la stanza, ma evidentemente non il suo piccolo cuore afflitto. Le sistemai sulle ginocchia una coperta da viaggio e le misi in grembo il suo manicotto di pelliccia affinché si scaldasse le gelide manine, poi uscii per ordinare alla mia governante qualcosa di caldo e corroborante. In tutto questo, la mia pallida paziente non aveva mai tolto la benda dagli occhi, e tuttora la teneva, forse per trovare rifugio alla stanchezza in quel vuoto foderato di raso nero senza riflessi.
La governante entrò poco dopo con una tazza di cioccolata fumante, me la consegnò e lasciò che fossi io a offrirla alla giovane sofferente, ma rimase al suo fianco con un tovagliolino candido pronta a nuovi ordini.
Dopo il primo sorso, la spossatezza sembrò prendere il sopravvento, e la testa si reclinò all’indietro sullo schienale imbottito, mentre le sfuggiva un lungo e doloroso sospiro.
Ma subito dopo, tornò a bere il liquido dolce e bollente e stavolta gli dedicò un’attenzione insolita: pareva che le sue papille gustative analizzassero freneticamente densità e sapore e stessero trasmettendo al cervello una corrente di segnali vorticosi. Al terzo sorso, più lungo e concentrato, esalò una parola:
“Cannella”.
“Come avete detto? – chiesi, perplesso.
“Cannella. Cioccolata con la cannella. Una spruzzata di cannella. Un nonnulla di cannella. Il vapore la scioglie e vi entra nel cuore”.
Bevve ancora, sempre cieca eppure visibilmente rianimata. E disse un’altra cosa stupefacente:
“Il capriccio del diavolo. La cannella: il capriccio del diavolo”.
Mentre cercavo di capire se fosse per caso uscita di senno, non mi accorsi del cambiamento avvenuto nell’espressione, solitamente riservata, della governante, che all’udire quelle parole si era impercettibilmente chinata verso la paziente e scrutava incredula il poco che restava visibile del suo volto velato.
“Avete veramente detto il capriccio del diavolo? – chiese con voce rotta dal turbamento.
Ed essa, la paziente smemorata, dal fondo del suo buio confermò con inattesa decisione:
“L’ho detto. La cannella sulla cioccolata è il capriccio del diavolo. Lo diceva sempre la mia bambinaia”.
La sua voce si era fatta sicura e io trasecolai, ma non ero pronto a quanto stava per accadere. Stavo per inserirmi con alcune domande prudenti e studiate per valutare il grado di completezza di quel primo ricordo che pareva affiorare, quando la governante mi rubò la scena e continuò il dialogo relegandomi a semplice ascoltatore.
“E ricordate come si chiamava, la vostra bambinaia? – indagò con trattenuto fervore.
La risposta arrivò dopo un istante:
“Berthe”.
La governante si coprì la bocca con le mani, colta da intensa emozione, ed esclamò:
“Madeleine, siete dunque voi?”
Madeleine si strappò la benda dagli occhi, i loro sguardi si ritrovarono e si riconobbero e davanti a me le due donne si abbracciarono singhiozzando di gioia e coprendosi di epiteti affettuosi ripescati nel passato.
“Madeleine, confettino mio, mia nuvoletta, mia colombella!”
“Berthe, mia fata buona, mio angelo, mia aurora boreale!”
“Avete riconosciuto la mia cioccolata!”
“Nessuno la fa come voi, nessuno ci mette la cannella!”
“E vi siete ricordata di me!”
“Chi mi è stata più vicina di voi quando ero piccina?”
Stravolto dall’epilogo inaspettato, non mi rimase che restare in disparte e assistere a quel fiume di ricordi che si snodava fra le due, a tratti gaio, a tratti commosso. Il muro nero si era dunque infranto? E quale pietosa divinità aveva posto Berthe, la mia decennale governante bretone, al centro di quella straordinaria guarigione? Forse il Caso, il più bizzarro di tutti gli dèi.
Nei giorni seguenti, la mia paziente compì rapidi e risolutivi progressi. Berthe la seguì amorevolmente nel percorso di riavvicinamento alla famiglia e i risultati non si fecero attendere.
Allo scadere del tempo di lutto, presentai a Madeleine la mia proposta di matrimonio ed essa accettò con cuore gonfio d’amore. Lo stesso amore che mi dedica da ormai quarant’anni e che si è manifestato nella nascita dei nostri tre figli e recentemente in quella dei nostri primi nipoti.
Berthe è rimasta sempre con noi, e quando la sua tenace salute bretone ha cominciato a venir meno l’abbiamo tenuta come una di famiglia, accudendola con affetto e gratitudine quanto lei aveva accudito tutti noi. Ci ha lasciato l’anno scorso, molto compianta. Negli ultimi tempi, una grave forma di artrite diffusa l’aveva immobilizzata a letto, ed essa, mostrandoci le sue povere mani deformi e ormai inutilizzabili, ci ammoniva con affetto:
“I ricordi non spariscono, tutt’al più si nascondono. I miei, li vedete, sono tutti qui: nelle mie ossa”.
(nell’immagine: Sul balcone, di Berthe Morisot)
E via, partecipiamo a questo eds Nero di Natale della solita stregonessa Donna Camèl, non lasciamoli soli, gli altri. Che sono:
Hombre con Ti prego, non chiamarmi Barbie
Dario con Zebre e savane
Leuconoe con Placida come il fiume
Pendolante con Natale con soffritto
Kermitilrospo con Pedalata nera
Fulvia con Il quadro capovolto – 2a parte
Lillina con Una vita segnata
Calikanto con Nero livido
La Donna Camèl con Se tu mi amassi
Singlemama con Dissolvenza in nero
Angela con Chi è di scena
Angela (ancora) con Taccido