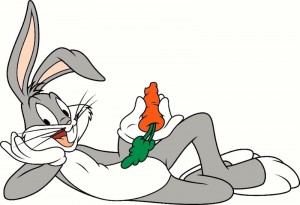Negli ultimi giorni di maggio – e delle sua vita – Zaira ricevette molte visite.
Negli ultimi giorni di maggio – e delle sua vita – Zaira ricevette molte visite.
Il dottor Gandolfi, anzitutto. Ogni mattina, prima di aprire l’ambulatorio, passava da lei nel suo alone di ottimo dopobarba e si intratteneva i pochi minuti che lei gli concedeva, giusto il tempo di un galante complimento per il colorito roseo e l’aspetto disteso del vecchio viso, che sapeva bene essere l’effetto di un discreto filo di cipria. Lei lo aspettava eretta sui cuscini del grande letto, fra lenzuola candide di corredo signorile e con un paio di civettuole pantofole azzurre lì a fianco, come a suggerire l’intenzione di alzarsi a momenti. Ma anche questa non era che un’elegante finzione, da entrambi accettata con altrettanta eleganza.
Per avere notizie sulla sua salute, il medico si rivolgeva a Clara, la governante, che in cucina gli serviva il caffè, un ottimo caffè distillato con pazienza goccia a goccia come non ne beveva in nessun altro salotto presso i suoi pazienti altolocati. Le chiedeva se avesse dormito e come, mangiato e quanto. Ne riceveva risposte generiche e riservate, come se la cosa non fosse affar suo. E non lo era, infatti. Non più. Da tempo Zaira non gli permetteva nemmeno di tastarle il polso, lo riceveva solo per cortesia ma senza dargli modo di esercitare il suo ministero.
Gioia, la nipote più giovane, si affacciava alla stanza più volte durante la settimana, di ritorno dalle lezioni. Le mostrava tutta entusiasta le foto del suo cucciolo, a volte le faceva ascoltare l’ultimo pezzo per oboe che stava studiando. Un’anima luminosa e vivace, e due mani piene di grazia. Dopo che se n’era andata, a Zaira sembrava che il tramonto indugiasse di più e più dorato dietro la vasta finestra, come quando era giovane lei. A quell’ora Clara le portava il tè nella tazza inglese, e lei gentilmente ne beveva giusto il numero di sorsi sufficienti per non deluderla. Poi chiedeva di restare da sola e cercava di assopirsi rivivendo le frasi e i sorrisi della nipote, che somigliava così tanto a lei e così poco a tutti gli altri della famiglia.
I figli venivano le domeniche, quasi tutte. Il caffè, una breve conversazione appropriata e generica, tanta formalità, la paura segreta di toccare temi troppo personali come la salute, il futuro. Si trovava sempre qualcosa di poco impegnativo di cui parlare, come una laurea, un viaggio, il nuovo giardiniere. Anche dopo quelle visite i pomeriggi sembravano non finire mai, ma il sapore che lasciavano non era dolce del tutto.
Le sembrava che maggio si stesse facendo sempre più caldo. A metà mattina il sole girava l’angolo della villa e lambiva la terrazza; Clara interveniva puntuale per accostare mezza imposta, solo mezza perché dal giardino saliva l’aria rinfrescata dall’irrigazione e il profumo delle rose antiche.
Dalle altre stanze a tratti le arrivava un tintinnio di tazzine o il ronzio attutito di un aspirapolvere. I rari squilli del campanello era in grado di distinguerli quasi sempre: il postino, i fornitori, il fattorino della lavanderia. Come le telefonate, non la riguardavano, o così aveva stabilito con se stessa da tempo. Le restavano il ventaglio, qualche libro sul comodino e le ombre che danzavano sullo specchio al movimento lieve delle tende.
Gesuina arrivò una sera sul tardi, da molto lontano. Venezuela. Qualcuno stava dando una festa in una villa nei paraggi, e le note di una musica sudamericana portarono con sé anche lei, dopo tanti anni, vestita da india e con le braccia scure di sole. L’ultima volta che l’aveva vista era una bambina in braccio a una monaca, e gliela stavano portando via perché la madre si era rifatta viva e la rivoleva, e lei aveva dovuto lasciarla andare e accettare di non saperne più nulla.
“Ma tu devi stare tranquilla”, le disse Gesuina. “Ho sposato un brav’uomo e siamo emigrati per sistemarci. Abbiamo messo su una piccola azienda, con campi, vacche, banani. Stiamo bene. I nostri figli lavorano con noi, ormai abbiamo anche i nipoti e possiamo invecchiare in pace”.
“Dicevo di te che eri figlia dei bombardamenti”, le ricordò Zaira affettuosamente. “Le bombe di gennaio ti fecero nascere prematura, e quelle di giugno sventrarono l’orfanotrofio dove ti avevano abbandonata e misero in fuga le monache. Ma prima riuscirono ad affidare alcuni bambini a famiglie che potevano, e tu venisti a noi, a me. Ho sempre saputo che era solo per un po’ di tempo. E fu infatti poco, due anni. Ma adesso sei tornata per dirmi che ce l’hai fatta”.
Si sentiva stanca, molto stanca, come dopo una grande felicità. Gesuina se ne andò lasciandola addormentata, e intanto la musica della festa si era smagliata tra le fronde degli oleandri e lungo il viale non restavano che i lampioni accesi e le loro falene intorno.
La luce nella stanza era diafana come se avesse nevicato. Zaira si disse che era troppo vecchia per stupirsi di qualcosa, e del resto sentiva freddo davvero. “Ora chiamo Clara e le chiedo una coperta”, pensò. Ma in quel momento qualcuno le posò un plaid scozzese sulle gambe, dispiegandolo con cura e senza peso. Le pareva già di stare meglio. “Grazie”, disse.
L’uomo con la giacca di tweed era tornato a sedersi di fronte a lei e aveva riaperto il libro che stava leggendo. Era uno sconosciuto, ma il sorriso con cui la guardava si sarebbe potuto definire amorevole.
“Jean, sei tu?”
“Sì. E noi siamo ancora sul notturno Parigi-Venezia”.
“Siamo fermi in Svizzera per la neve?”
“Stanno lavorando sulla linea. Gli inservienti stanno distribuendo coperte, dicono che ripartiremo verso mattina”.
Zaira rifletté.
“Tu stai andando a un convegno a Milano”.
“E tu a rivedere tuo padre in ospedale. Sei molto in ansia, temi di non arrivare in tempo”.
“Ho fatto in tempo. Mi ha aspettato”.
Zaira tornò a chiudere gli occhi. Si sentiva al sicuro con Jean accanto. Da lontano le sembrava di sentire il raschio degli attrezzi degli spalaneve, tra gli alti pini delle alpi svizzere. Era come tornare bambina la notte di Natale, col sonno leggero e i fruscii dell’inverno dietro le finestre. Soprattutto con la certezza che qualcuno vegliasse su di lei. Anche se era un perfetto sconosciuto con il quale divideva ore insolite di un viaggio notturno. O forse a maggior ragione.
C’era stato un bacio, sì. Alcuni baci. Nati dall’attesa, dall’incertezza, dalla tenerezza di due solitudini in mezzo a una notte molto lunga e molto sospesa. Niente di più, solo un lieve ricordo negli anni, come di un dono giunto per caso al momento giusto lontanissimo da casa.
“Ecco”, disse Jean dopo un po’.
“Ci stiamo muovendo?”
“Ha smesso di nevicare. È tutto ciò che so”.
Erano nuvole estive. O forse le tende leggere che oscillavano appena alla brezza di mezzogiorno. No, non erano nemmeno quelle. Era Guido che varcava adagio la soglia della terrazza in completo di lino bianco. Come le tende, come le nuvole.
“Ti sta benissimo, quel completo da crociera”, gli disse Zaira dopo averlo studiato.
“È per il nostro giro del mondo, ricordi?”
Aveva sempre quel sorriso malandrino, invecchiato con lui e con le loro vite.
“E quando ci imbarchiamo?”
“Appena sei pronta”.
“Ma i bambini?”, chiese Zaira con improvvisa apprensione.
“Sono in buone mani, stai tranquilla. Ora è il nostro momento e non pensare ad altro”.
“Non vorrei dimenticare niente, lo sai come sono fatta”.
Guido girellava per la stanza col suo Panama in mano, osservando oziosamente i dettagli che quasi settant’anni prima avevano curato insieme. Soprammobili, lampade, fotografie, gli stucchi francesi del caminetto.
“Questa puoi lasciarla qui”, disse indicando la fleboclisi accanto al letto, di cui Zaira non si era ancora accorta. “Partiamo leggeri”.
“Leggeri. Sì, lo sono. È una bella sensazione, forse è la prima volta che la provo”.
La mano di Guido sopra la sua aveva il tocco più familiare del mondo, era come aver ritrovato il pezzo mancante e averlo rimesso al suo posto su misura, combaciava senza sforzo, alla stessa temperatura e col medesimo diafano peso.
“Allora dici che posso venire così come sono?” gli chiese un’ultima volta.
“Sei bellissima così come sei”, e a quelle parole l’anello nuziale che le ballava sul dito smagrito gettò un bagliore complice.
“E com’è il mare?”
Si lessero a lungo negli occhi, che avevano entrambi azzurri, trovando insieme e nello stesso istante la risposta che avevano saputo da sempre. Com’è il mare? Com’è il mare?
“Calmo e profondo”.