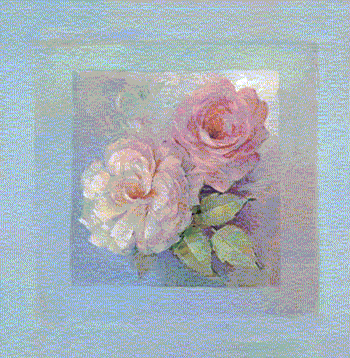È MORTO
PIER MARIA PASINETTI
VENEZIANO, SCRITTORE E MIO MAESTRO
Poco più di un anno fa ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona: un desiderio che coltivavo da decenni, da quando ho scoperto i suoi romanzi così straordinari e così veneziani, ai tempi del ginnasio.
E poco fa il telegiornale regionale ha annunciato la sua morte, alla venerabile età di 93 anni.
Stasera sono triste per lui, che mi mancherà. Così gli dedico questa pagina del mio blog ripostando la cronaca di quell’unico incontro, del quale manterrò il più affettuoso e riconoscente dei ricordi.
Se qualcuno desidera conoscere meglio questo Autore eccellente ma schivo e per nulla presenzialista, sul mio sito, nella sezione libri letti, troverà alcune recensioni che lo riguardano.

14 giugno 2005, Venezia, Aula Magna dell’Ateneo Veneto: alle ore 18, presentazione dell’ultimo romanzo di Pier Maria Pasinetti, “A proposito di Astolfo”, edito da Helvetia e nelle librerie in questi giorni.
Il portone monumentale dell’Ateneo Veneto è scrostato e sprangato, sembrerebbe da secoli. Un caffè lì vicino ha accampato davanti due file di tavolini e sedie impagliate, oggi deserti perché pioviggina. L’ingresso, allora, è in calle; giro l’angolo, abbandono la luminosità plumbea di campo san Fantin e percorro alcuni metri in una luce bassa, da corridoio di teatro. La porticina a vetri è stretta e anonima, illuminata dall’interno da luci altrettanto basse e discrete, come quando vengono calate per segnalare l’inizio di uno spettacolo. Spazio angusto, quasi domestico; sembra l’ingresso di una casa veneziana, con una scala lunga e stretta che sale ripida verso un pianerottolo, poi gira e si perde. Ma subito a destra un’altra porta, più ampia e spalancata: la sala dell’Aula Magna, col rosso delle poltroncine (semplici sedie severamente allineate) e gli affreschi sulle alte pareti attorno ai finestroni opachi. Soffitto a cassettoni altrettanto affrescato, inserti di marmo in giro, senso di una solennità equilibrata, non invadente. Bellezza, insomma, ma non autoreferenziale, in una città in cui la bellezza è tratto di natura e non tronfia ricerca.
Non c’è ancora nessuno. Mi sembra di essere entrata in una chiesa prima di un rito. Al posto del sacrestano, Daniela si aggira festosa ma in ritardo con locandine e dépliants da distribuire; un abbraccio – siamo emozionate entrambe – e poi le do una mano come si trattasse di imbandire una festa scolastica. Arriva il libraio con una sacca delle copie del nuovo libro che tra poco verrà celebrato; lo conosco, il libraio, titolare della più veneziana delle librerie veneziane, antro stretto e vivissimo dove i volumi sono ammucchiati dappertutto, ospiti o protagonisti – amici, meglio – e non merce senza nome né calore.
Arrivano altri, ora più rapidamente e a gruppi. L’atmosfera aumenta di tono e temperatura, persone che si conoscono oppure si riconoscono solo per il fatto di essere comunque in questo posto significativo, simbolo della storia e della cultura veneziana e non solo da qualcosa come duecento anni. Per lo più donne e non giovani, espressione di quello che più tardi qualcuno, sulla pedana, annuncerà come “l’harem di Pasinetti”: scopro anche io che è sul pubblico femminile che hanno avuto da sempre più presa le storie e lo stile di questo Autore, che in effetti a molte splendide figure femminili ha dedicato ritratti leggeri, ironici e innamorati in ognuno dei suoi romanzi. Giovani, pochissimi. Non frequentano questo genere di incontri oppure non frequentano questo genere di letteratura, il romanzo, che in Italia oggi come oggi è del resto così scarsamente e mediocremente interpretato. Oppure ancora non conoscono Pasinetti, scrittore di razza ma da sempre indifferente alla pubblicità, osservatore distratto e incidentale della sua stessa fama, araba fenice nel mondo letterario della sua patria, dalla quale ha vissuto lontano la maggior parte dell’anno nella maggior parte degli ultimi 40 o 50 anni.
C’è un minimo di ritardo. Annunciano che il Maestro è arrivato in Ateneo e ora sta riposando qualche minuto prima di presentarsi. Corrono i sussurri, le confidenze, le informazioni locali: ultranovantenne, da tempo malandato in salute, il femore in tempi recenti, stato più di là che di qua, ma lucido sapesse: lu-ci-dis-si-mo. E scrive ancora, le sue memorie adesso; c’è già un titolo (un titolo di coda) che a pelle intuisco come la struggente anteprima del suo addio, “Fatepartire le immagini”. Io intanto con la mia macchinina digitale faccio alcune prove, neanche a dirlo fallimentari.
Poi entra. Entra in scena da una porticina laterale, sorretto da persone amorose e compiaciute, mettendo avanti prima delle gambe impacciate un curioso bastone verde chiaro, cui si appoggia con curiosità lui stesso, quasi a non riconoscergli altra identità che quella di un giocattolo di gusto improbabile che qualcuno ha insistito per giudicare confacente alla sua inferma età. È alto e diritto malgrado ciò, conserva il portamento del bell’uomo che è stato e che ci restituiscono le rare fotografie pubbliche. Indossa una camicia aperta e un cardigan di lana grigio scuro: indossa cioè il suo ruolo di vecchio e familiare pensionato veneziano, e insieme l’aria domestica di un padre o di un nonno strappato per un’ora alla sua sedia di cucina, alla radio accesa, al giornale spiegato sul tavolo con accanto una scatolina di mentine, o pasticche per il cuore. Nel sedersi con teatrale sollievo sulla poltroncina centrale, emette un sospiro teatrale anch’esso nella sua autoironia: “Semo qua!”, cioè siamo qua, finalmente; seduti comodi dopo la stancata, la camminata, questa fatica di arrivare fino a noi che è una delle quotidiane sue fatiche necessarie, in una città dove si invecchia a piedi arrancando senza misericordia, se non si vuole restare fermi del tutto dietro una finestra.
Dalla mia sedia subito sotto la pedana, piccola io e insaccato lui in una poltrona fonda, e per di più con un microfono davanti, vedo e guardo e non me ne stacco fino alla fine solo il suo viso, vagamente sconcertato mentre ascolta dubbioso i colti panegirici dei suoi due ospiti. Sembra colto di sorpresa e poco convinto che le loro ordinate analisi riguardino lui; sembra chiedersi se non stiano esagerando per quella pelosa cortesia che si deve ai vecchi, per di più malandati. Infatti, invitato, commenta: “Beh, ciò, se è tutto vero allora vuol dire che son proprio bravo!”. La platea si estasia e lo adora.
Altre cose, dice, poche e un po’ slegate, col tono di smitizzare, di prendere le distanze dalla celebrazione, di indicare la strada sensata e più congeniale dell’ironia, del ridimensionamento affettuoso. A chi cerca di attribuirgli metafore e di ottenere da lui spiegazioni, chiavi, messaggi, non dà molta corda, avvertendo – ma come dovesse essere evidente a tutti – che le sue storie, nomi/cognomi/località/amori & lutti compresi, sono inventate, tutte inventate. Dal suo sornione incanto si scuote un attimo per intervenire su una parola che non gli è sfuggita e che trova fuori luogo: il termine laico, cui – citando se stesso – assegna il valore di parola-zero. Sul tema della morale e del trascendente, che qualcuno invoca con un certo azzardo, ha un monito saldissimo da affermare, e ce lo trasmette con un improvviso destarsi del tono di voce, che ora è serissimo e fermo davanti a questa semplice immensa verità: “Bisogna sempre agire in modo da rendersi minimamente presentabili a se stessi”. Rifiuta il confronto col soprannaturale, la morale di Pasinetti, e ribadisce la centralità della coscienza, del qui, dell’oggi. La platea incamera, riflette, tende a condividere. Io, nel mio piccolo, mi alzerei in piedi, ma non mi vedrebbe nessuno. Neanche lui che all’inizio ci ha informati esilarato di avere con sé solo gli occhiali per vicino.
I discorsi, applauditi, si esauriscono, le domande dalla sala ottengono risposte ormai per lo più umoristiche ed evasive: il Vecchio non ci sta, ai confronti animati e dottorali, persiste nella sua tattica naturale, quella di ridurre il rito alle dimensioni di un incontro familiare, ai toni semplici e pacati che in fondo spiegano meglio e di più.
Prima del commiato, gli si fanno attorno molti con l’offerta di auguri e la richiesta di dediche. Ho la mia copia in mano e sento il viso che mi si scalda, che brilla credo, mentre lo avvicino anche io. Senza sgomitare, trovo un pertugio: lo trovo perché si è girato e ha incontrato i miei occhi, facendomi un cenno. Mi faccio avanti, lo saluto “Maestro”, vorrei dirgli che lo amo, ma lui lo sa, perché mi prende una mano fra le sue e mi guarda fisso e mi comunica che noi due ci conosciamo. Non è vero, ma ci credo. Mi chiede il mio nome, e mi conferma che ci conosciamo, anzi mi esorta a cercare con lui nel passato l’anello di congiunzione. Mi soggioga. Sto al gioco: elenchiamo incerti ma speranzosi alcuni omonimi, collocandoli nel tempo, nello spazio, nelle parentele, nelle professioni. Risaliamo – ma per me è un viaggio ormai sublunare – a certe conoscenze veneziane di suo padre, remotamente medico in questa città, e questa pare la chiave che chiarisce e conforta entrambi. Non è vero, ma ci credo. Ora qualcuno dietro preme e sbuffa, ma la mia mano è sempre tra le sue in quel modo così naturale e riposato che sembra fare di me una sua parente di sangue, vissuta lontana per tanto tempo e ora tornata, come lui del resto, alla base, alle mura domestiche, al posto giusto. Sono io che devo accomiatarmi, dopo aver raccolto il libro dove ora c’è per sempre una frase di affetto e augurio e la sua firma che per la malfermità della mano – mi spiega – da tempo usa abbreviare. Sguscio via, altri se lo inghiottono, non mi giro neanche più, saluto rapidamente qualcuno ed esco in calle, ancora non è notte, stringendomi dentro già una nostalgia.
Avrei voluto aspettare che se ne andassero tutti, poi porgergli il suo buffo bastone verde e sorreggerlo per un gomito – lui così più alto di me – mentre lo accompagnavo adagio verso casa, alla sua sedia di cucina, alla sua tazza di caffè d’orzo, alle pastiglie per la gamba, per il cuore, per i ricordi. In mezzo a un campiello, lo so, si sarebbe fermato per declamare come al teatrino dei preti qualcosa del Macbeth, ma in inglese, così non lo avrei capito ma ugualmente me lo sarei bevuto di gusto.
Invece avevo un treno in attesa, un interregionale delle venti e qualcosa, semivuoto. Quando è partito imboccando il ponte sulla laguna per approdare in terraferma, ero già a pagina 36.
Questa è la sua scheda biografica:

Veneziano, quindi cosmopolita per nascita, Pasinetti ha diviso la sua vita fra Venezia e gli Stati Uniti, dove ha tenuto corsi di letteratura generale nella sede di Los Angeles della University of California. L’Università di Yale gli ha conferito il dottorato.
Tra i diversi riconoscimenti ricevuti ricordiamo il premio del National Institute of Arts and Letters di New York, il premio Scanno, il premio Amelia, il premio Pisa, il premio Ecureuil. Ha ottenuto per due volte il premio Selezione Campiello.
Ha pubblicato diversi romanzi: il primo, Rosso veneziano (1957) ottiene già un buon successo al punto che ne cura egli stesso la traduzione in inglese per il mercato americano.
La prima versione de La confusione esce nel 1964, ma viene successivamente riveduta e riedita nel 1988 col titolo Il sorriso del Leone.
Con Il ponte dell’Accademia (1968), offre la prima netta e sorprendente indicazione di un nuovo e più efficace uso del linguaggio, di una scelta (geniale) di forme verbali e strutturali basate sì su una straordinaria padronanza del mezzo, ma proprio grazie a essa volte a sfruttarne ancora meglio e per vie prima poco esplorate le potenzialità espressive.
Segue nel 1971 Domani improvvisamente, che rappresenta un ulteriore progresso e una nuova sorpresa nel percorso letterario di PMP, il quale anche qua sperimenta in modo originale e felicissimo una invidiabile libertà di scrittura, magistrale modello per una narrativa – quella italiana – spesso ripetitiva e asfittica.
È del 1979 Il Centro e del 1983 Dorsoduro, che prende il titolo da un sestiere di Venezia amatissimo e legato alle sue molte memorie; poi ancora nel 1993 Melodramma, curiosamente ambientato nell’ottocento, e più recentemente Piccole veneziane complicate nel 1996, anno in cui consegue il prestigioso premio Ecureuil.
Solo quest’anno (2005) viene a pubblicazione, per le Edizioni Helvetia, anche la sua ultima opera, A proposito di Astolfo, ulteriore esempio della sua capacità di innovare e rinnovarsi.
Altri suoi libri sono: L’ira di Dio (tre racconti, 1943); Dall’estrema America (reportage, 1974); Life for Arts (saggio critico, 1985).
Insieme al fratello Francesco, noto cineasta che fu tra i fondatori del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, in giovane età aveva fondato la rivista “Il Ventuno”. Dopo la morte prematura del fratello è rimasto sempre legato al mondo del cinema, scrivendo diverse sceneggiature e collaborando con grandi registi.
Recentemente rientrato dagli Stati Uniti, si era stabilito in via definitiva nella sua Venezia, dove è nato nel lontano 1913.