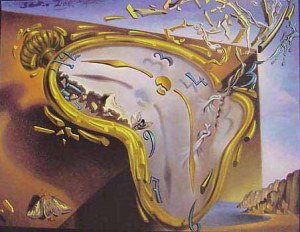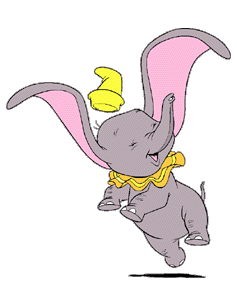L’anno che chiusero la fabbrica e misero in strada quasi duecento operai, io ero un poppante ancora attaccato al seno di mia madre, perciò questa storia me l’hanno raccontata dopo, ma c’è da crederci.
Mio padre, che era un rosso di quelli irriducibili, dapprima arringò i compagni con comizi ringhiosi, poi li convinse a incatenarsi con lui davanti al municipio, e alla fine organizzò la resistenza a oltranza. Con un manipolo di incazzati a morte si installò sul coperto dello stabilimento e proclamò col megafono l’intenzione di rimanervi senza scendere fino a che il padrone non avesse fatto marcia indietro. Furono compilati dei turni, stesi degli elenchi di generi di sopravvivenza, pitturate delle lenzuola con slogan battaglieri, e la guerra di resistenza ebbe inizio ai primi di dicembre, un’alba buia e annegata nel nebbione padano. Parenti e amici, dal piazzale, salutavano gli eroi che si arrampicavano sul tetto portando in spalla rotoli di coperte e sacchetti di viveri. Da lassù, una volta arrivati, si affacciarono come scalatori giunti in vetta all’Everest e agitarono striscioni presaghi di vittoria.
Mia madre quel mattino a quell’ora stava preparando il caffelatte per i miei fratelli che andavano a scuola, con me attaccato alle tette. Il suo uomo lo aveva salutato la notte prima, brontolando molto perché a lei quella storia pareva una bravata da imbecilli. Due volte al giorno, con le altre mogli e sostenitrici, portava il pranzo agli assediati, i quali calavano cesti e panieri pieni di panni da lavare e li recuperavano colmi di cartocci di cibi caldi. Inneggiavano, gli stolti, e le donne un po’ si commovevano e un po’ si innervosivano. Alcune addirittura già il secondo giorno cominciarono a imprecare mentre schiaffavano il ben di Dio in quei panieri e poi dovevano tornare a casa e dividere avanzi con il resto della famiglia. Mia madre era una di queste ultime, perché con un marito senza stipendio che perdeva tempo a fare il Robinson Crusoe su un tetto invece di cercarsi un altro lavoro non è che se la passasse molto bene.
Faceva freddo, i fossi gelavano, i miei fratelli più piccoli dovevano percorrere tre chilometri di sterrato fangoso per andare a scuola, e appena uscivano di casa la mamma spegneva la stufa per riaccenderla solo alle quattro, quando tornavano. Per racimolare qualcosa, si portava a casa la roba da stirare delle signore del quartiere nuovo, ma di più non poteva fare perché non aveva nessuno a cui affidarmi. Tutti speravano che il padrone si lasciasse intenerire per Natale, invece ovviamente non avvenne, né sarebbe potuto avvenire dato che il padrone se l’era filata da tempo in Sudamerica. Avvenne invece che i comitati di sostegno, i sindacati e la Caritas, per mostrare la loro vicinanza agli operai asserragliati, cominciarono a fare collette per fornirli di qualche comodità in più, che ne so, stufette, indumenti pesanti, casse di liquori forti, un televisore, il nuovo calendario Pirelli.
Io intanto mi ero preso una bronchite per via della stufa spenta, così adesso, oltre al cibo di tutti i giorni e alle bollette della luce, mia madre doveva lasciar giù dei soldi anche al farmacista. Mia madre si imbacuccò, mi affidò temporaneamente alla perpetua del canonico e si avviò alla fabbrica, decisa a salire su quel dannato tetto e a trascinare suo marito alle proprie responsabilità. Arrivata in cima, anzitutto le toccò difendersi dai grossolani complimenti degli operai, che erano a digiuno di donne da quasi un mese, e poi affrontò il marito, che sembrava il più esaltato e allegro di tutti, e infatti per l’allegria prima le rise in faccia e poi la insultò, rispedendola al suo posto, che secondo lui era quello accanto alla stufa a fare la calza mentre gli uomini erano in prima linea a rischiare la salute per il futuro delle famiglie.
Quando scese, rossa in viso per l’indignazione, tutte le altre donne le si fecero intorno per sentire come avesse trovato la situazione.
“Stanno benone, ve lo dico io! Non gli manca niente, hanno le tende, le coperte, le stufette, le carte, la grappa, il televisore, i giornaletti sporchi e pure il pallone quando fa bel tempo. ‘Sti disgraziati! E noi a cucinargli i mangiarini e a lavargli le mutande! E i bambini con i buchi nelle scarpe! E il piccolo con la bronchite! E il padrone in Sudamerica! E intanto chi è che tira la carretta, eh? Indovinate un po’! Ma aspettate che scendano (perché prima o poi scendono, eh se scendono!), e non so voi ma io il mio lo faccio correre, a gambe levate lo faccio correre!”
Mia madre era così: la vera rossa della famiglia, la vera sindacalista, la vera lottatrice, era lei. La mattina dopo, prese la carriola, mi ci sistemò dentro ben infagottato e scarriolò baldanzosa fino all’emporio. Gastone era nel retro.
“Tu mi devi qualcosa – lo apostrofò lei con aria decisa.
Lui arrossì:
“È passato tanto tempo, avevo vent’anni…”
“Io invece sedici. Ero minorenne – gli ricordò lei, implacabile.
“Cosa vuoi? – si arrese Gastone, temendo conseguenze imbarazzanti.
E lei glielo disse. Voleva un sacco di farina, mezzo chilo di lievito, due chili di burro, due di zucchero e trenta uova. A credito, ché se le cose fossero andate per il verso giusto, lo avrebbe pagato entro un mese fino all’ultimo, miserabile centesimo.
Mia madre passò tutta la notte a cuocere torte. La mattina dopo, era domenica, le impilò nella carriola, coperta da una tovaglia pulita, e andò a venderle sul sagrato all’uscita dalla messa grande. Aveva preparato un cartello: Torta Proletaria della Rosina, fatta a mano e genuina. Il primo ad avvicinarsi fu il Maresciallo dei Carabinieri, che con aria di disapprovazione le chiese:
“Ma Rosina, ce l’hai la licenza?”
E la Rosina, che non aveva paura della verità, gli rispose dura:
“La licenza no, però ho quattro figli, e un marito sul tetto della fabbrica”.
Le prime torte andarono a ruba: tutti volevano un dolce fatto in casa per il pranzo domenicale, compreso il farmacista, le signore del quartiere nuovo e perfino la fornaia, che le chiese la ricetta. Mia madre gliela diede (“Le solite cose, farina, zucchero, uova, burro e lievito”) ma tenne per sé i suoi due ingredienti segreti, cosicché nessuna delle massaie che tentò di riprodurre l’ottima Torta Proletaria della Rosina otteneva lo stesso risultato di gonfiezza e leggerezza.
Il giorno dopo cominciarono ad arrivare le prime ordinazioni. La torta era squisita, si scioglieva nel latte della prima colazione, accompagnava i bambini a scuola nel cestino della merenda, completava degnamente un pranzo e si presentava trionfante agli ospiti. Mia madre infornava torte tutta la notte, e le vendeva nella sua cucina. A mio padre non la fece neanche assaggiare: gli portava ogni giorno la minestra, lo spezzatino, le melanzane alla parmigiana, ma la torta no.
Era ormai primavera. Io gattonavo. Mio fratello maggiore, quando seppe che sarebbe stato bocciato, lasciò la scuola e si occupò delle consegne a domicilio. Il papà, lassù sul tetto, cominciava a smaniare perché aveva voglia di andare a pesca, ma si era preso un impegno e gli seccava darsi per vinto, anche se ormai le piogge avevano dilavato gli striscioni e i giornaletti sporchi erano venuti a noia.
Una volta la settimana il Sindaco andava sotto la fabbrica – che stava ormai vistosamente arrugginendo – e gridava:
“Dai, scendete. Non serve a niente. Vi troviamo un lavoretto, in qualche modo si farà!”
Ma loro volevano riavere il posto in fabbrica, mica accettare un impiego da spazzino o da becchino.
In capo a un mese mia madre si era fatta una fama. Le sue torte partivano ogni mattina per i clienti del paese e dei dintorni. Erano Torte Proletarie a prezzo proletario, perché mia madre era onestissima, però chi chiedeva delle varianti pagava qualcosa di più, perché gli ingredienti extra costavano. Nacquero ed ebbero successo la Torta Proletaria con le mandorle, quella con le mele, quella con il maraschino e la ricotta, e infinite altre. Mia madre aveva ripulito e imbiancato il vecchio capanno degli attrezzi e aveva trasferito lì il suo laboratorio di pasticceria. Tutto andava a gonfie vele. Io fui svezzato a colpi di torta, e questo è il ricordo più remoto che ho della mia infanzia.
Il Primo Maggio i vigili del fuoco fecero una sortita: salirono sul tetto e riportarono giù i dimostranti, che opposero una resistenza solo formale. Da settimane annusavano, da lassù, il profumo di torta che aleggiava costantemente sul paese, e fu questo senza dubbio a farli capitolare. Quel giorno, le vendite della Torta Proletaria registrarono un picco mai visto, il primo di una serie ininterrotta a tutt’oggi.
Il papà entrò in casa mogio mogio. La mamma lo spedì a lavarsi, poi lo rifocillò, gli mostrò le pagelle dei figli e il conto del farmacista, e la mattina dopo lo mandò all’Ufficio Collocamento, dove il Sindaco aveva messo una buona parola per un posto di lava-auto in un garage. Probabilmente lo riprese anche nel suo letto, perché l’anno dopo nacque un altro bamboccio, una femmina che adesso studia da estetista.
Oggi compio ventun anni. Li ho passati quasi tutti nella pasticceria di mia madre, in piazza. Mia madre è diventata un’imprenditrice: in laboratorio ha quattro aiutanti, e due ragazze stanno al banco. Lei arriva per prima, se ne va per ultima, passa le giornate a impastare e decorare, esce ogni tanto nel suo grembiule immacolato per salutare qualche cliente di riguardo, ma non ne vuole sapere di lasciare il suo posto al tavolo di lavoro. Mio padre quest’anno è andato in pensione: ora trascorre i pomeriggi al bar con gli amici di un tempo e continuano il torneo di scopa iniziato sul tetto quand’erano giovani combattenti e martiri del lavoro. I miei fratelli e le mie sorelle si sono sistemati tutti; quello bocciato ha poi ripreso gli studi e adesso fa il commercialista per l’azienda di famiglia. Io sono diventato capo-pasticcere e ho anche inventato nuove torte di tendenza (al kiwi, alla papaia, ipocaloriche, senza glutine) che però non supereranno mai la gloriosa Torta Proletaria di mia madre, sempre in vetta alla classifiche e esportata ormai in tutto il mondo.
Per il mio compleanno, mia madre mi ha fatto una sorpresa: sull’insegna, accanto al suo nome, è comparso il mio. “Rosina e Figlio“, c’è scritto adesso. Ora che sono diventato ufficialmente suo socio ed erede, ho finalmente avuto accesso al segreto dei suoi ingredienti speciali, quelli mai rivelati a nessuno e responsabili della universalmente acclamata unicità delle sue torte. Me li ha confidati solennemente.
“Incazzatura per impastare, coraggio per lievitare. Senza questi due trucchi non si arriva da nessuna parte. Tienilo bene a mente, Tonino”.
Mia madre, che gran donna. Mi chiedo dove sarebbe arrivata se fosse entrata in politica.